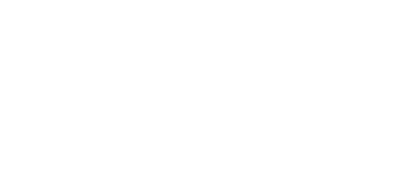Alfonso Iozzo e Domenico Moro
Commento n. 258 - 22 marzo 2023
Come sostiene un analista politico indiano, Shivshankar Menon, “nessuno vuole l’attuale ordine mondiale” (Foreign Affairs, 3 agosto 2022). Ma il fatto è che i maggiori protagonisti della politica mondiale promuovono politiche che lo aggravano, indebolendo sempre più le istituzioni multilaterali, piuttosto che cercare soluzioni comuni ai principali problemi mondiali.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è la più tragica delle politiche che mettono in discussione l’attuale ordine mondiale. Ma il fatto che, alle Nazioni Unite, molti paesi africani, asiatici e latino-americani, che pur hanno solidi legami con l’Occidente, si siano rifiutati di seguirlo nelle sanzioni alla Russia è, allo stesso tempo, l’indicazione che non riconoscono la leadership occidentale dell’attuale ordine mondiale e dell’incertezza sulla configurazione che esso può assumere in futuro. La Cina, da parte sua, ha in corso dispute territoriali con il Giappone, il Vietnam, l’India ed altri paesi asiatici. Gli Stati Uniti, cui va il merito storico di aver dato vita alle istituzioni multilaterali, oggi le mettono in discussione. L’Amministrazione Biden pratica politiche che, con l’approvazione dell’Inflation Reduction Act, non solo mettono in discussione le regole della WTO, ma si rifiutano di rispettarle quando gli USA vengono condannati per i dazi sull’acciaio e l’alluminio introdotti dall’Amministrazione Trump.
L’ordine mondiale successivo alla caduta dell’URSS è stato definito da molti analisti un ordine unipolare. Ma gli USA non hanno impiegato il loro maggior potere per promuovere il rafforzamento delle istituzioni multilaterali, ritenendo piuttosto di poter imporre, ricorrendo anche alla forza militare, e in modo unilaterale, uno specifico modello politico-economico. Il fallimento dell’esperienza irachena, afghana e – con la primaria responsabilità di alcuni paesi europei – di quella libica, stanno a dimostrare che non vi sono scorciatoie all’affermazione dei valori universali della libertà e della democrazia, se questo sforzo non è sostenuto da un consenso mondiale e inserito in un piano di lungo termine.
Resta il fatto che i principali antagonisti della leadership americana, siano essi la Cina, la Russia e la stessa India, non sono stati in grado, almeno fino ad oggi, di offrire al resto del mondo un convincente modello politico alternativo a quelli che, durante la Guerra fredda, gli Stati Uniti da un lato e l’URSS dall’altro, avevano saputo proporre, i primi nei confronti del mondo occidentale e la seconda nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Se questo è vero, bisogna però evitare di cadere nell’errore di pensare ad un modello di ordine mondiale che si basi sulla proposta di un solo paese. Se emergerà un nuovo assetto mondiale, questo non potrà che essere il frutto di una scelta condivisa da tutti gli attori mondiali o, quantomeno, dai principali e non potrà che fondarsi sul funzionamento autonomo delle istituzioni multilaterali e non sulla benevolenza di una o poche potenze mondiali. Il punto è che un nuovo assetto mondiale non può nascere spontaneamente, ma occorre che qualche paese prenda un’iniziativa in tal senso e, soprattutto, che sia credibile.
L’ipotesi che viene qui avanzata è che questo “paese” non possa che essere l’Unione europea (UE). Come è stato fatto notare recentemente, l’UE ha un interesse esistenziale a difendere un mondo che funzioni sulla base di regole condivise, proprio perché essa ha prosperato e si è rafforzata in base a regole condivise dai propri membri e può sopravvivere solo in un mondo che funzioni in base a regole mondiali. Pensare che i principali problemi mondiali, dalla sicurezza, alla tutela dell’ambiente, alla difesa contro le pandemie, alla gestione dell’immenso debito pubblico dei paesi in via di sviluppo, possano essere affrontati in base alla politica ottocentesca dell’equilibrio tra le maggiori potenze, è semplicemente irrealistico.
Se l’UE vuole però essere plausibile in questo sforzo, deve essere in grado di assumere un’iniziativa in un settore dove, più di altri, si stanno addensando i maggiori pericoli per il futuro dell’umanità e questo settore è quello della sicurezza. La crescente instabilità politica mondiale è infatti all’origine del più alto livello di spese militari (circa 2.000 miliardi di dollari nel 2021), che il mondo abbia mai raggiunto, pur nella fase dell’emergenza sanitaria mondiale che, caso mai, avrebbe dovuto suggerire maggiori investimenti in questo settore.
Quale può essere il passo che può compiere l’UE, per essere credibile, oltre al fatto che sta diventando urgente il rafforzamento e l’integrazione della sua politica estera e di difesa? Questo passo non può che essere tratto dalla sua storia, che è stata una storia di due conflitti mondiali ed è la ragione per la quale, per evitarne altri, alcuni paesi europei hanno introdotto un importante principio nelle loro Costituzioni. Negli anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale, Francia, Germania ed Italia, nelle rispettive Costituzioni, riconoscono che efficaci organizzazioni internazionali sono necessarie per prevenire nuove guerre. Pertanto, in ciascuna di esse è prevista la possibilità di introdurre limiti alla sovranità nazionale, o il trasferimento di parte dei poteri sovrani, ad istituzioni mondiali. Per quanto riguarda la Francia, si tratta del Preambolo della Costituzione della Quarta Repubblica, richiamato in quello della Costituzione del 1958; nel caso della Germania è l’art. 24 della Legge Fondamentale; mentre per l’Italia si tratta dell’art. 11 della Costituzione. Queste previsioni costituzionali sono state alla base del successo del progetto di unificazione europea.
La proposta è pertanto che l’UE inserisca nella propria “costituzione” un articolo che sul modello, ad esempio, della Costituzione italiana, affermi che: “L'UE ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Un tentativo in tal senso era già stato fatto durante i lavori della Convenzione europea presieduta da Valery Giscard d’Estaing, ma non ebbe successo. L’aggressione russa all’Ucraina e le conseguenze che può avere per la pace in Europa e nel mondo, se questa tendenza non viene corretta, possono ridare nuovo impulso a questa proposta.
* Alfonso Iozzo è Presidente del Centro Studi sul Federalismo; Domenico Moro è membro del Consiglio Direttivo e Coordinatore dell’Area Sicurezza e Difesa del Centro Studi sul Federalismo

 It
It  En
En