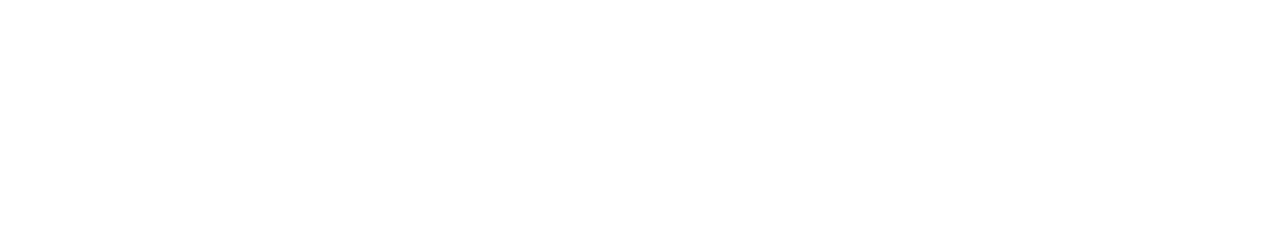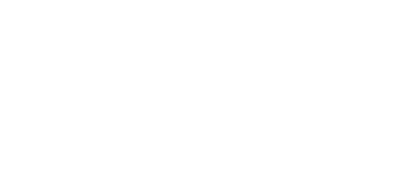Andrea Cofelice
Commento n. 176 - 15 aprile 2020
È indubbio che limitazioni significative ad alcune libertà fondamentali, per quanto dolorose, siano necessarie per limitare la diffusione del Covid-19 e contribuire a salvare vite umane. Ma fino a che punto uno Stato può spingersi nel derogare ai propri obblighi in materia di tutela dei diritti fondamentali e dello stato di diritto in situazioni di emergenza? È una vexata quaestio che accompagna lo sviluppo del moderno diritto internazionale dei diritti umani sin dalla sua nascita.
Gli stessi trattati in materia ammettono possibilità di deroghe (si vedano l’art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 15 della Convenzione europea sui diritti umani), imponendo, al contempo, precise e stringenti condizioni. Primo: una compressione dei diritti si giustifica solo in presenza di un’emergenza pubblica che “minaccia la vita della nazione”: per esser tale, la minaccia deve essere attuale o imminente, di carattere eccezionale, e talmente grave da mettere a rischio la continuità della vita organizzata dell’intera comunità nazionale. Secondo: le limitazioni devono essere necessarie (devono rispondere a un “bisogno sociale urgente”) e proporzionate nella portata e negli effetti, in modo tale da non eccedere il limite “strettamente richiesto dalle esigenze della situazione”. Terzo: le restrizioni devono essere regolate dalla legge in modo trasparente ed avere preferibilmente un fondamento costituzionale. Quarto: necessità e proporzionalità delle misure adottate devono essere soggette a monitoraggio e vigilanza, a livello nazionale e internazionale. Tale supervisione è di primaria importanza, poiché i governi potrebbero abusare del proprio margine discrezionale, con misure sproporzionate o perseguendo scopi differenti.
Alcuni diritti, tuttavia, non sono derogabili. Si tratta, in particolare, dei cosiddetti “diritti assoluti”: diritto alla vita, principio di non-discriminazione, divieto di tortura, divieto di riduzione in schiavitù, e principio nullum crimen, nulla poena sine lege. Inoltre, la Commissione di Venezia ed il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite hanno ribadito che, proprio al fine di preservare i meccanismi nazionali di vigilanza, il rispetto dello stato di diritto deve prevalere anche in situazioni di emergenza. Il riferimento, in particolare, è al principio di legalità, separazione dei poteri, partecipazione democratica, libertà di espressione, indipendenza del sistema giudiziario, diritto di accesso alla giustizia e ad un ricorso effettivo, diritti delle minoranze, tutela della privacy.
Tali premesse rappresentano il test necessario per valutare la legittimità delle misure adottate dagli Stati europei per far fronte all’attuale pandemia. Ancora una volta, l’Ungheria rappresenta un caso limite: i poteri di decretazione esclusivi ottenuti dal premier Orbán, grazie ad una legge approvata a larga maggioranza dal Parlamento lo scorso 30 marzo, sono in palese contrasto con i criteri di necessità, proporzionalità ed il rispetto tout court dello stato di diritto. A preoccupare, in particolare, sono tre elementi: la mancanza di contrappesi istituzionali (il premier è autorizzato, in maniera discrezionale, a sospendere i lavori parlamentari e a rinviare eventuali elezioni); un’ulteriore compressione della libertà di espressione (con la possibilità di comminare gravi sanzioni penali a chi diffonda notizie che il governo giudichi inappropriate), nell’ambito di un sistema mediatico e giudiziario già minati nella loro indipendenza; l’assenza di qualsiasi limite temporale e ratione materiae alla decretazione d’urgenza (secondo una recente analisi, grazie ai “pieni poteri” il premier Orbán avrebbe fin da subito adottato ben 15 decreti, nessuno dei quali strettamente richiesto dalle esigenze di contrasto al coronavirus, ma finalizzati a sottrarre importanti competenze amministrative ai comuni). Tendenze analoghe volte a comprimere specifici aspetti dello stato di diritto, seppur meno gravi e sistematiche, stanno attraversando anche altri paesi.
La pandemia di Covid-19 rappresenta, al contempo, uno stress test per valutare l’efficacia degli strumenti di cui l’UE dispone per monitorare il rispetto dello stato di diritto da parte dei suoi membri. Come già chiarito in un precedente Commento, ad oggi esistono due meccanismi (rule of law toolbox): uno di natura giurisdizionale, consistente nel ricorso di infrazione promosso dalla Commissione; l’altro di natura politica, ai sensi dell’art. 7 TUE, azionabile dal Consiglio.
Nel caso delle misure adottate dal governo ungherese, ancora una volta il Consiglio si è mostrato indisponibile a ricorrere al meccanismo dell’art. 7, per mancanza di volontà politica e per l’oggettiva difficoltà, a causa delle note divisioni interne, di raggiungere le maggioranze richieste (quattro quinti per le misure preventive; unanimità per le sanzioni): un gruppo di 13 Paesi si è pertanto limitato a sottoscrivere una nota di condanna. Ben più promettente appare la possibilità di ricorrere alla procedura di infrazione, ipotizzata dalla Presidente von der Leyen e dal Commissario alla giustizia Reynders, visto lo score di sentenze adottate dalla Corte di giustizia dell’UE (CGUE) per precedenti violazioni dello stato di diritto proprio in Ungheria e Polonia.
Anche questo meccanismo, tuttavia, andrebbe rafforzato: attualmente la CGUE impiega in media 40 mesi per decidere sui casi di infrazione, durante i quali il pregiudizio inferto al sistema democratico nazionale può diventare difficilmente reversibile. Sarebbe opportuno agire su tre fronti: adottare procedimenti accelerati e semplificati (sull’esempio delle “sentenze pilota” della Corte europea dei diritti umani); ricorrere in maniera sistematica a ordinanze provvisorie da parte della CGUE per sospendere immediatamente, in vista del giudizio finale, l’efficacia di misure nazionali manifestamente in contrasto con lo stato di diritto (si veda l’ordinanza dell’8 aprile con cui la CGUE intima alla Polonia di sospendere le misure di controllo disciplinare dei giudici); consentire al Parlamento Europeo (PE), con opportuna maggioranza qualificata, di poter attivare procedure di infrazione.
A consolidare tale quadro concorreranno due nuovi meccanismi. In primo luogo, la pubblicazione, prevista per settembre, della prima Relazione annuale sullo stato di diritto da parte della Commissione: uno strumento di monitoraggio generalizzato e periodico, che coinvolge tutti gli Stati membri e le istituzioni europee, annunciato già negli Orientamenti politici della Presidente von der Leyen, anche in risposta alle sollecitazioni provenienti da PE (risoluzioni del 2016 e 2018) e società civile. La Relazione illustrerà buone pratiche ed elementi di criticità, conterrà raccomandazioni pertinenti e offrirà a Commissione e Consiglio una base più solida e obiettiva per attivare il meccanismo dell’art. 7 o eventuali procedure di infrazione.
Infine, l’auspicio è che possa finalmente essere adottata da Consiglio e Parlamento la proposta di istituire una sorta di meccanismo di condizionalità (generalmente utilizzato nelle relazioni esterne) all’interno del quadro finanziario pluriennale dell’UE. Tale proposta, formalizzata dalla Commissione già nel 2018, prevede l’adozione di misure commisurate alla gravità delle violazioni dello stato di diritto in un paese membro, tra cui la sospensione o riduzione dei finanziamenti nell’ambito degli impegni esistenti, o il divieto di concludere nuovi impegni. In ogni caso, è vitale che le istituzioni europee sappiano reagire fermamente alla plateale erosione dello stato di diritto in alcuni Stati membri, preservando i principi costitutivi dell’Unione.
*Ricercatore al Centro Studi sul Federalismo


 It
It  En
En