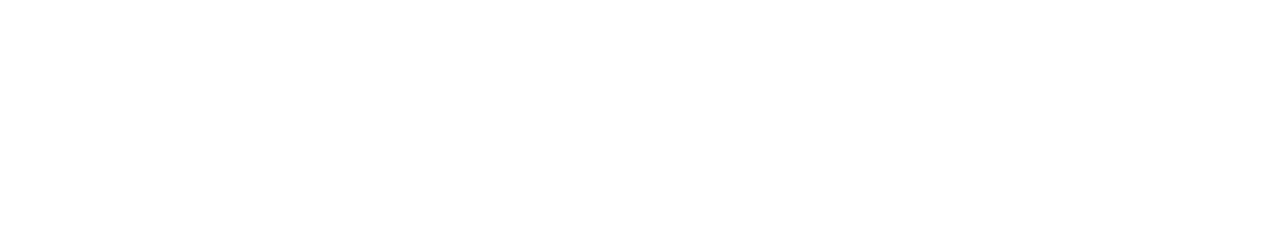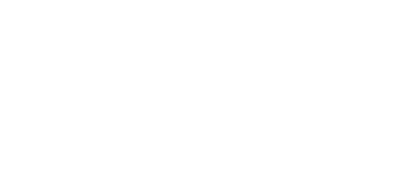Flavio Brugnoli / 10 giugno 2024
Commento n. 299
Il Parlamento europeo è “l’unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini”. E dal 6 al 9 giugno i cittadini dell’Unione europea (Ue) si sono espressi sulla loro idea di Europa, purtroppo con un’affluenza in significativo calo in Italia. Nondimeno, una consultazione con un bacino elettorale di 370 milioni di aventi diritto offre una miriade di spunti di riflessione, sull’esito del voto e sulle prospettive che apre (e forse chiude). Per provare a farlo, è utile allargare lo sguardo al di là di splendori e miserie della recente campagna elettorale, per guardare anche all’evoluzione istituzionale che ha preceduto l’appuntamento con le urne.
Questi mesi preelettorali hanno confermato quanto dimensione nazionale e dimensione europea siano ormai intrecciate. Quella che vediamo è un’interazione dinamica fra livello nazionale e livello europeo: temi come il Green Deal, la difesa europea, Next Generation EU (NGEU) e il PNRR dominano tanto il confronto nazionale quanto quello europeo, ipotesi di alleanze o veti europei si riverberano sugli assetti politici nazionali, perfino il numero delle preferenze viene usato per pesarsi e “contare” al tavolo del Consiglio europeo. Si è parlato, giustamente, di politica “euro-nazionale”: un successo dell’Ue di cui forse non abbiamo piena consapevolezza, una interdipendenza confermata anche dalla triste fine delle illusioni dei fautori della Brexit.
L’esito di un’elezione parlamentare si valuta anzitutto dall’assemblea che scaturisce da quel voto, l’Europarlamento non fa eccezione. E va rimarcata la forza di un Parlamento che sta in carica cinque anni e non può essere sciolto, protagonista inaggirabile dell’ordinamento europeo. I dati sui seggi mostrano una tenuta della maggioranza “europeista” (PPE+S&D+RE ne avrebbero poco più di 400 su 720) che ha guidato la legislatura precedente – e che sarà incalzata da una più forte opposizione “sovranista”. Ma il voto europeo retroagisce anche sulla sfera nazionale: il successo elettorale delle destre colpisce il motore (già non poco imballato) franco-tedesco, col Presidente Macron che gioca la carta azzardata delle elezioni anticipate e il Cancelliere Scholz che vede l’SPD scavalcata dall’AfD, primo partito nella ex-Germania Est – un esito che purtroppo è stato accolto con comprensibile soddisfazione a Mosca.
Negli ultimi due decenni, nella “democrazia rappresentativa” europea abbiamo visto una tensione permanente fra due diverse spinte istituzionali. Da un lato, la spinta intergovernativa, accentuata dalla necessità di risposte emergenziali alla crisi economica esplosa nel 2008; dall’altro, una spinta alla parlamentarizzazione del sistema, con una espansione di ruolo e poteri del Parlamento europeo. Una tensione che accompagna passaggi diversi dell’Ue e che rispecchia la sua natura di “unione di Stati e di popoli” (in cui i primi non sono i “cattivi” e i secondi i “buoni” dell’avventura europea). E che si traduce in quella sorta di “bicameralismo imperfetto” in cui il potere di co-decisione accomuna Parlamento e Consiglio dell’Unione europea.
Il dopo voto apre, com’è noto, la fase delle nomine dei vertici delle istituzioni europee. Molta attenzione si è concentrata sulle prospettive dei “candidati principali”, iniziativa dei partiti europei di successo nel 2014, meno nel 2019. Una procedura istituzionale – che ha dovuto accettare anche Ursula von der Leyen, Spitzenkandidat del PPE – che in realtà incarna un processo politico, un tentativo di affermare un più forte primato parlamentare rispetto a chi rappresenta gli Stati. Vedremo se la candidata che presumibilmente sarà “proposta” dal Consiglio europeo saprà costruirsi una maggioranza (eventualmente allargandola ai Verdi) sufficiente per farsi “eleggere”, a voto segreto, dal Parlamento europeo.
L’apertura della nuova agenda europea si preannuncia accidentata, con la presidenza semestrale del Consiglio affidata, dal 1° luglio, all’Ungheria filorussa di Orbán, e la prima riunione del Consiglio europeo, il 28-29 giugno, alla vigilia del primo turno delle elezioni nazionali francesi. Va inoltre ricordato che quello che leader e partiti europei avranno di fronte sarà un “pacchetto di nomine” di vertice: Commissione, Consiglio europeo, Alto Rappresentante (e Presidente del Parlamento). Un’equazione che tradizionalmente deve bilanciare una pluralità di variabili – gruppi politici, provenienza geografica, vecchi/nuovi e grandi/piccoli Stati membri, parità di genere – e che sembra lasciare poco spazio a nomi esterni, pur autorevolissimi.
Fra i grandi capitoli che la nascente legislatura europea dovrà affrontare vi è la preparazione dell’allargamento, ai Balcani occidentali, a Ucraina e Moldova, forse alla Georgia. È difficile sottovalutare la complessità dell’integrare nell’Unione un paese come l’Ucraina, martoriato da una guerra d’aggressione e con davanti enormi costi per la ricostruzione – sempre che la guerra scatenata da Putin non degeneri in modo catastrofico. Ma è evidente che né l’architettura istituzionale né le risorse del bilancio pluriennale dell’Unione sono adeguate a un passaggio a 35-36 membri. Su questo si era già mosso il Parlamento uscente; che cosa farà quello entrante?
II 22 novembre 2023 il Parlamento europeo aveva approvato una proposta di riforma con 245 emendamenti al Trattato di Lisbona e (soprattutto) la richiesta al Consiglio europeo di convocare una Convenzione. Il nuovo Parlamento confermerà quella proposta, malgrado il peso accresciuto delle forze sovraniste? Il Consiglio europeo valuterà la proposta, non fosse altro per “leale collaborazione” fra istituzioni europee? Salvo poi affossarla per la nota opposizione di una maggioranza dei suoi membri? Difficile anche pensare a un’azione “costituente” (modello Spinelli 1984) da parte di un Parlamento europeo più freddo su questi temi. Rimane il fatto che il dovere storico dell’allargamento non potrà che tenere vivo il tema dell’“approfondimento” dell’Unione.
La (prima?) Commissione von der Leyen puntava a essere “geopolitica”, consapevole che ad essere in gioco era ed è il ruolo dell’Unione in un mondo diventato multipolare e più conflittuale. Fino alla esplosione di due guerre, che hanno reso prioritario il tema della “difesa europea”. Tanto più in vista dell’ulteriore terremoto che innescherebbe una rielezione di Donald Trump alla presidenza degli USA. Una difesa intesa quale pilastro europeo rafforzato della NATO (grazie anche all’ingresso di Finlandia e Svezia), capace di agire “con gli alleati quando possibile, da sola quando necessario”. Ma non gioca a favore dell’Unione il “fattore tempo”, con minacce incombenti e progetti comuni di lunga e difficile gestazione. Per contro, i vincoli di bilancio degli Stati membri potrebbero aprire la via a eurobond per un sostegno coordinato alla difesa europea.
Sul versante economico, l’Ue sarà chiamata a un difficile equilibrio fra breve e medio-lungo termine. La “doppia transizione”, ecologica e digitale, dovrà rimanere il pilastro di un’economia sostenibile, innestandosi su una nuova politica industriale europea. Un elemento chiave per una “autonomia strategica” europea, in un contesto globale sempre più “muscolare” (dalla BRI cinese all’IRA statunitense). Fondamentale sarà anche il successo di NGEU, a partire dal PNRR italiano, per aprire la via a un bilancio europeo dotato di maggiori risorse proprie, che affianchi il nuovo Patto di Stabilità e Crescita, incentrato (sul modello di NGEU) su impegni nazionali per riforme e investimenti, affiancati da una salutare vigilanza sui rischi legati al forte indebitamento.
Il voto in Italia per le europee merita (in altra sede) ampie riflessioni, ma conferma quell’intreccio “euro-nazionale” che è la nuova cifra della politica europea. Starà all’attuale maggioranza di governo e a chi la guida decidere se svolgere un ruolo originale nell’avanzamento dell’Unione europea (in particolare sul tema della difesa) o uno di retroguardia, di zavorra dell’integrazione, che finirebbe per ritorcersi contro i valori e gli interessi dell’Italia europea.
*Direttore del Centro Studi sul Federalismo
Download PDF - Commento n. 299
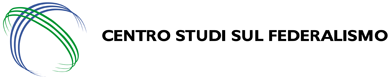

 It
It  En
En