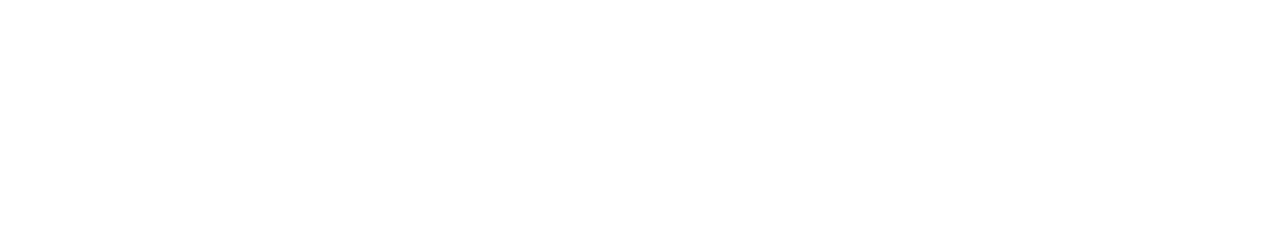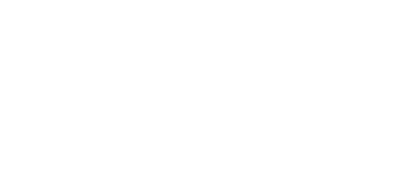Olimpia Fontana / 17 dicembre 2024
Commento n. 308
Dopo i ripetuti avvertimenti lanciati da Mario Draghi ai leader europei, sembra finalmente affermarsi una consapevolezza dello stato in cui versa la competitività europea, intesa come prosperità e sicurezza in un mondo geo-politicamente instabile. Nella recente Dichiarazione di Budapest il Consiglio europeo afferma che “occorre sfruttare in modo globale e coerente tutti gli strumenti e le politiche, a livello sia dell'Ue che degli Stati membri. Non è più possibile mantenere lo status quo”. A livello di principio si riconosce la necessità di sostenere, anche con denaro pubblico a livello europeo, i diversi “fattori della competitività” europea, come una politica industriale improntata alla doppia transizione (ecologica e digitale), un rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa, investimenti in ricerca e innovazione. Tuttavia, anche in vista delle negoziazioni sul futuro Quadro finanziario pluriennale 2028-2035, molto ancora resta da discutere.
Il dibattito può essere ricondotto al tema dei “Beni Pubblici Europei” (BPE), che solleva questioni fondamentali per il processo di integrazione: in quali settori, per quali politiche, l’Ue dovrebbe spendere di più e con quali mezzi dovrebbe sostenere una maggiore spesa europea, in tempi di crescente debito pubblico e aumento delle sfide da affrontare? La natura della discussione quindi più che sul se, si concentra sulla definizione di che cosa e come l’Ue dovrebbe fare di più. Già da un decennio la Commissione europea persegue un approccio policy-driven al bilancio europeo, che nelle programmazioni finanziarie del 2014-2020 e 2021-2027 ha portato a un ridimensionamento delle politiche a basso valore aggiunto europeo (PAC e Politica di Coesione) in favore di voci di spesa legate ai BPE (per es. ricerca e innovazione).
Nella situazione attuale, densa di sfide e di rischi per il modello economico europeo, c’è da chiedersi perché nonostante sussistano forti motivazioni a “sfruttare tutti gli strumenti e i mezzi per raggiungere i nostri obiettivi”, ancora si fatichi a procedere verso una maggiore fornitura di BPE. Il dibattito riguarda almeno due aspetti: uno concerne la questione di definire quali BPE, l’altro quello delle risorse per finanziarli, ovvero l’introduzione (permanente) di una capacità fiscale europea.
Partendo dal secondo aspetto, un primo fattore che complica la discussione sui BPE riguarda l’esperienza del Next Generation EU (NGEU): se da una parte di tratta di uno strumento innovativo per l’emissione cospicua di titoli di debito europeo, dall’altra su di esso pesano valutazioni negative in termini di rispetto dei criteri e capacità di spesa dei governi riceventi. Con un’eredità simile, una volta concluso il NGEU sarà più complicato chiedere nuove forme di debito comune, soprattutto da parte dei paesi che più hanno beneficiato dello slancio di solidarietà emerso in risposta al Covid (come l’Italia).
In secondo luogo, la mole di investimenti richiesta per la competitività europea è enorme rispetto a quanto messo in campo finora. Se il NGEU è un piano di investimenti da 750 miliardi in sei anni (2021-2026), il Rapporto Draghi parla di 800 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno. A fronte di queste cifre è ragionevole puntare anche su altre vie per mobilitare gli investimenti privati, in particolare l’Unione dei Capitali, come raccomandato dal Rapporto Letta. Tuttavia, viste la difficoltà riscontrate finora su questo progetto, la via di un bilancio europeo potenziato (almeno di dimensioni del 4% del Pil, secondo alcuni studi) va tenuta in primo piano.
In terzo luogo, l’auspicato aumento del bilancio europeo deve essere accompagnato dall’ introduzione di nuove risorse proprie europee. I “fattori della competitività” sopra menzionati non saranno raggiungibili solamente attraverso le risorse nazionali dei paesi, né mediante le risorse aggiuntive disposte dal NGEU, in scadenza. Saranno richieste, oltre all’auspicata mobilizzazione della finanza privata, altri strumenti di capacità fiscale europea permanente, sulla base di una roadmap per le risorse proprie in fase di attuazione.
Infine, a essere cruciale in sede di accordo politico tra paesi membri saranno i dettagli su quali BPE concentrarsi. Tra gli studiosi la discussione è solitamente fondata su considerazioni di efficienza economica, alla ricerca dei criteri che permettono di legittimare un trasferimento di competenze al livello europeo. Tali fattori, in base alla teoria del federalismo fiscale, riguardano la presenza di economie di scala e di effetti di ricaduta (spillover effects). In sostanza, conviene spostare la fornitura di beni e servizi a livello europeo perché ciò porterebbe a una riduzione dei costi e delle duplicazioni; inoltre, una fornitura nazionale potrebbe produrre effetti a beneficio (o a scapito) di altri paesi. Quindi, meglio centralizzare.
Tuttavia, una valutazione prettamente economica (ammesso sia possibile farla) può non essere sufficiente e, del resto, non rispecchia ciò che è successo nella storia dell’Ue. La politica regionale, il progetto (ancora incompiuto) di una difesa comune, la creazione di debito pubblico europeo legato al NGEU, sono esempi di spesa comune europea dettata da specifiche circostanze storiche e da dinamiche politiche, che poco hanno a che vedere col solo calcolo razionale suggerito dalla teoria economica. Da una parte, i tentativi di aumentare la spesa pubblica europea hanno funzionato quando tale spesa è stata ben mirata, definita in modo chiaro; dall’altra, però, lo sforzo per valutare sulla base di criteri oggettivi il trasferimento di competenze può ritardare l’accordo politico.
In un interessante contributo per ASTRID, Buti e Messori si interrogano sulla possibilità di procedere con ulteriori cessioni di sovranità all’Ue, per la produzione di BPE, in modo che rispecchino gli interessi dei singoli paesi. E distinguono fra BPE “innovativi”, come quelli a sostegno della doppia transizione, e BPE “solidaristici”, riconducibili al welfare. Ciascun paese effettua valutazioni in base alla propria forza relativa, in termini sia di struttura produttiva, tessuto economico-sociale, grado di accentramento statale, sia di peso politico nel processo decisionale europeo. Secondo la loro analisi, i paesi membri “forti” nelle suddette dimensioni, ma politicamente deboli, risulterebbero favorevoli ai BPE in infrastrutture e innovazione, ma contrari a ulteriori cessioni di sovranità (caposaldo della loro posizione “frugale” nell’Ue), nel timore che il loro debole potere contrattuale li porti a subire aumenti di spesa pubblica contrari al loro interesse nazionale, per esempio in BPE a sostegno del già forte welfare nazionale. Le posizioni dei singoli paesi membri in merito alla cessione di sovranità possono, quindi, essere influenzate dal timore che l’Ue finanzi i BPE “sbagliati”.
Le discussioni sul futuro dell’Ue e sui suoi fattori di competitività dovranno tenere al centro del dibattito il tema della produzione e del finanziamento dei BPE, partendo da quelli legati alla doppia transizione. Oggi, come in passato, il dibattito non dovrà prevedere solo valutazioni oggettive di convenienza economica, dettate dalla teoria, ma anche una chiara definizione degli specifici BPE su cui l’Ue deve puntare. Del resto, le circostanze geo-politiche internazionali, seppur preoccupanti per il modello economico europeo, non potrebbero essere più pressanti per un avanzamento nel processo di integrazione.
*Mario Albertini Fellow del Centro Studi sul Federalismo e Ricercatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.


 It
It  En
En