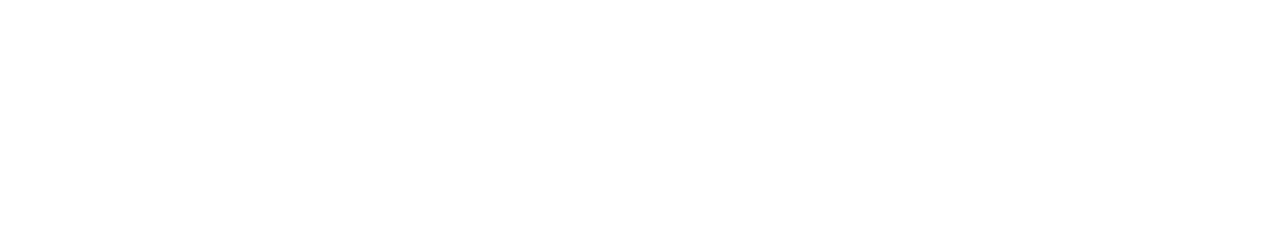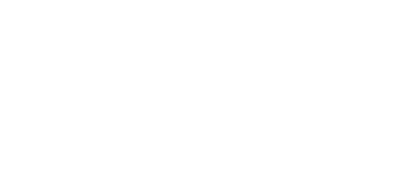Olimpia Fontana
Commento n. 168 - 6 marzo 2020
I lavori per giungere a un accordo sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea (Ue) sono in una fase di stallo. I margini di trattativa sembrano rimpicciolirsi sempre di più, nei negoziati di quello che sarà il primo bilancio pluriennale dell’Ue senza il Regno Unito. In pratica, con minori risorse per 12 miliardi di euro l’anno.
Il Consiglio europeo straordinario che si è tenuto il 20 e 21 febbraio è stato animato dalla netta contrapposizione tra gruppi di paesi. Da una parte i frugal four (Austria, Olanda, Danimarca e Svezia), che a fronte della perdita del secondo maggiore contribuente invitano l’Ue a “non fare il passo più lungo della gamba” (quindi, con un bilancio fermo all’1% del Pil dell’Ue) e, viste le minori disponibilità, a dare priorità a politiche quali sicurezza, gestione delle migrazioni e sostenibilità ambientale. Dall’altra i friends of cohesion che chiedono che la politica di coesione non subisca tagli, con un budget più ambizioso, in linea con la posizione espressa del Parlamento europeo (1,3% del Pil Ue). Il dibattito si declina quindi su due livelli, uno quantitativo circa l’ammontare del bilancio, l’altro qualitativo sul suo effettivo utilizzo. Il round negoziale ha avuto esito negativo, per le divergenze sulla dimensione effettiva del bilancio. Contrasti che tengono in ostaggio ogni decisione in merito alla distribuzione delle risorse per voci di spesa. Una dinamica che dipende in definitiva dalla posizione relativa di ciascun paese, contribuente o beneficiario netto, rispetto al bilancio comunitario.
Nel 2018 la Commissione europea, cui spetta l’iniziativa sul bilancio, proponeva un budget pari all’1,11%. Due anni dopo, la nuova Commissione Von der Leyen cerca il consenso delle parti offrendo un bilancio inferiore (1,07%) e rimodulandone la distribuzione con tagli a voci di spesa prima ritenute prioritarie (ricerca e innovazione, spazio, difesa e missioni di pace) a vantaggio delle politiche tradizionali (politica agricola e di coesione). Un cambio di direzione rispetto a quando l’allora Commissario europeo per il bilancio, Günther Oettinger, affermava che, per far fronte al vuoto finanziario post-Brexit, sarebbero stati i programmi nuovi a subire i minori tagli e a beneficiare di maggiori risorse aggiuntive. Oggi, a pochi mesi dal termine entro il quale il Consiglio Ue e il Parlamento europeo dovranno trovare un accordo, si assiste a un gioco al ribasso che mette in luce la difficoltà dei paesi membri di pensare al bilancio comunitario come strumento per far fronte alle nuove sfide dell’Ue.
Da molti anni si discute di riformare il bilancio dell’Ue dal lato delle fonti: la via di uscita per vedere aumentare il bilancio sarebbe quella di introdurre genuine risorse proprie, giustificandone la creazione ponendola in relazione alle nuove politiche dell’Ue. L’occasione per un cambiamento è data oggi dall’ambizioso programma con cui l’Unione punta a diventare, entro il 2050, un’economia a zero emissioni di CO2 (lo European Green Deal, EGD), ma soprattutto dall’ammontare di investimenti, 100 miliardi di euro l’anno, che il programma prevede. L’EGD stesso è oggetto di dispute, perché i friends of cohesion vorrebbero che il nuovo Just Transition Fund, ideato per rendere la transizione ambientale socialmente accettabile nelle regioni più dipendenti dal carbone, disponesse di risorse aggiuntive (7,5 miliardi di euro), non riciclate dalla politica di coesione.
Una proposta che circola da anni è quella di introdurre una carbon tax come strumento per disincentivare l’uso di fonti fossili e allo stesso tempo generare introiti per i bilanci pubblici. Una soluzione che sarebbe ottimale da un punto di vista ambientale, ma di difficile applicazione sul piano politico e sociale. La Commissione intende perseguire la strada del carbon pricing, attraverso forme di Border Carbon Adjustment (BCA), una tariffa sulle importazioni commisurata alla quantità di CO2 emessa durante la produzione del bene importato. L’obiettivo è eliminare le differenza tra giurisdizioni in ambito di politica ambientale e prevenire la delocalizzazione della produzione industriale verso paesi dove le regole sono carenti o più deboli. Questa proposta è particolarmente sensata nell’Ue per tre ragioni.
Primo, il commercio estero è una fonte importante di emissioni. In Europa le emissioni da un punto di vista di produzione interna sono diminuite, ma va considerato anche il lato della domanda dei consumatori finali, i quali contribuiscono per via indiretta a generare emissioni, ovunque la produzione avvenga. Una larga fetta di beni prodotti in Cina, una delle principali emittenti di CO2, viene esportata verso l’Ue, dove i consumatori beneficiano di prodotti a prezzi più convenienti. Per alcuni paesi, come Italia, Francia e Svezia, più del 30% delle emissioni nazionali deriva dalle importazioni. Una BCA potrebbe ridurre l’impatto negativo che il commercio internazionale ha sulle emissioni globali, scoraggiando la delocalizzazione della produzione verso paesi con standard ambientali poco ambiziosi.
Secondo, in Europa esiste già un’infrastruttura di carbon pricing domestico di cui potersi avvalere per applicare la BCA. Essa potrebbe essere introdotta sotto forma di acquisto di permessi a emettere, così come avviene oggi all’interno dell’Ue per le industrie ad alta intensità energetica ed esposte al commercio estero. In pratica si tratterebbe di un’estensione dell’Emission Trading System (ETS), in cui gli importatori sarebbero soggetti allo stesso obbligo dei produttori nazionali di restituire i permessi in base al contenuto di carbonio dei beni importati. Il vantaggio pratico rispetto a una carbon border tax sarebbe quello di evitare il passaggio del voto all’unanimità in sede di Consiglio, richiesto per una imposta europea, nonché di beneficiare di un capitale tecnico e politico già esistente.
Infine, ciò che più conta ai fini dei negoziati sul futuro bilancio dell’Ue, l’introduzione di una BCA potrebbe generare introiti consistenti. Secondo un recente studio dell’Istituto austriaco di ricerca economica (WIFO) il gettito prodotto da una misura di questo tipo, che affluirebbe direttamente al bilancio comunitario, rientrando nella politica doganale di competenza esclusiva dell’Ue, potrebbe arrivare a finanziare entro il 2027 tutto il bilancio comunitario. Tale disponibilità finanziaria cambierebbe i termini dei negoziati, potendo sostenere sia gli investimenti dell’EGD sia, attraverso il coordinamento con la politica di coesione, le misure a supporto della “giusta transizione”.
Per arrivare a una BCA, anche in forma di quote ETS, ci vorrà del tempo e alcuni aspetti, sul piano internazionale, sono ancora da approfondire: anche su questo sta lavorando la Commissione europea. Ma sono anni che si parla di riformare il bilancio, senza che nulla cambi e le sfide che l’Ue sarà chiamata ad affrontare nei prossimi tempi saranno sempre più impegnative. è il momento di iniziare a concentrarsi sul nodo delle risorse, che rende i negoziati sulla programmazione pluriennale sempre così complicati.
*Ricercatrice al Centro Studi sul Federalismo


 It
It  En
En