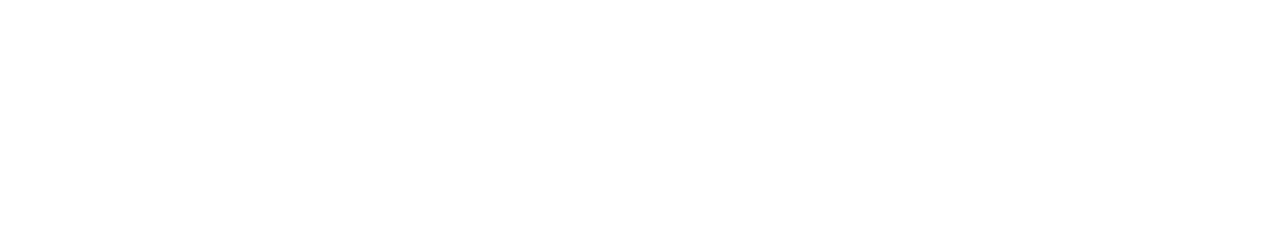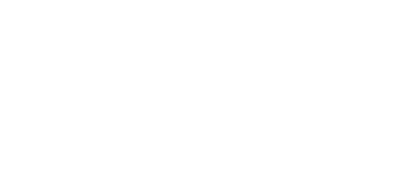Flavio Brugnoli
Commento n. 228 - 13 settembre 2021
I vent’anni che vanno dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 al caotico ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan sono stati segnati da una molteplicità di crisi: da quella economico-finanziaria del 2007-2008 a quella migratoria, da quella climatica a quella scatenata dal coronavirus. Un arco di tempo in cui abbiamo toccato con mano quanto sia sottile, nell’epoca dell’interdipendenza globale, il confine tra dimensione interna e dimensione esterna dei problemi. L’Unione europea (Ue) è stata costretta ad affrontare sfide drammatiche, che hanno rischiato di minarne le fondamenta. Ma anche di fronte al disastro afghano la domanda rimane la stessa: quale potrebbe e quale dovrebbe essere il posto dell’Ue in un mondo in costante – e talvolta inquietante – cambiamento?
Il sistema multilaterale costruito nel secondo dopoguerra era basato su regole e istituzioni sovranazionali, con gli Stati Uniti quale potenza egemone. Un assetto consono all’Ue, fondata anch’essa su regole cooperative e istituzioni condivise. Il multilateralismo ha accompagnato la fase ascendente della globalizzazione, che ha beneficiato sia i paesi sviluppati sia quelli in via di sviluppo. L’emersione di nuovi giganti, a partire da Cina e India, e i guasti provocati dalla ipertrofia finanziaria dell’economia hanno fatto venire allo scoperto anche i costi sociali della globalizzazione. Brexit, l’elezione di Trump (con il suo America First), la crescita di una destra populista sono state anche risposte di corto respiro a quella crisi, che ci hanno costretto a interrogarci sul futuro dell’Ue.
Tuttavia, in parallelo è cresciuta una consapevolezza diffusa – talvolta prima nell’opinione pubblica che nella politica e nelle istituzioni – che ci sono dei “beni pubblici globali” che gli Stati da soli non sono più in grado di garantire. Pensiamo all’ambiente, alla sicurezza, alla sanità (tanto più di fronte alla pandemia), alla sostenibilità del sistema economico. Tutti temi che ruotano, in modi diversi, intorno a quello della ricerca di “protezione” da parte dei cittadini. Questa chiave di lettura può aiutarci a comprendere le scelte strategiche recenti dell’Ue e a disegnare un suo possibile profilo internazionale.
Una doverosa premessa: quando guardiamo all’Ue in termini comparati non è per ora il caso di eccedere nel pessimismo. Malgrado le crisi (passate e in corso), l’Unione rimane l’area economica sovranazionale più integrata del pianeta, un terzo del suo reddito dipende dagli scambi di beni e servizi con l’estero, ha nell’euro la seconda valuta a livello mondiale, vanta un “modello sociale” in larga misura senza paragoni negli altri continenti. Ma su scala globale nessuna di queste acquisizioni è scontata e per sempre.
La risposta alle sfide poste dai “beni pubblici globali” è il filo conduttore della strategia che si è data, a fine 2019, la Commissione guidata da Ursula von der Leyen: la “doppia transizione”, verde e digitale, affiancata dalla (generica) consapevolezza di dover essere una Commissione “geopolitica”. Lo European Green Deal, architrave del nuovo modello di sviluppo, avrà un grande impatto anche sulla proiezione esterna dell’Ue, in termini di riduzione della nostra dipendenza energetica, di definizione di standard mondiali sulla riduzione delle emissioni e la neutralità climatica (entro il 2050), di diffusione di strumenti quali il Carbon border adjustment mechanism, contro il dumping climatico da parte di paesi inquinatori.
Allo stesso tempo, la transizione digitale porta in primo piano il tema della “sovranità tecnologica europea”, in un mondo dominato dai giganti privati del digitale (americani e cinesi), in cui i dati sono la “materia prima” più importante e la cybersecurity una priorità vitale. L’Ue sta già puntando, in più campi strategici, sia a creare dei “campioni europei” in grado di competere su scala globale sia a diventare più selettiva nei confronti degli investimenti dall’estero. Anche questo è un caposaldo del tema, trasversale, della “autonomia strategica” europea.
La pandemia e il Covid-19 hanno mostrato all’Europa quanto possano essere fragili le “catene del valore” globali. L’Ue ha toccato con mano i rischi sia delle delocalizzazioni nella produzione di materiale sanitario sia di una sua debole capacità di ricerca e produttiva in materia di vaccini. Certo le reti produttive globali conservano molti aspetti positivi e in ogni caso non sempre sono facilmente reversibili. Ma in tutto il mondo vediamo tendenze alla “regionalizzazione della globalizzazione”. Si pensi a mega-accordi commerciali quali la Trans-Pacific Partnership (da cui gli USA di Trump si sono autoesclusi), la Regional Comprehensive Economic Partnership (che vede insieme Cina, Giappone, Corea del Sud), l’African Continental Free Trade Agreement (che riunisce 54 Paesi).
Anche la risposta alle conseguenze economiche della pandemia apre nuove opportunità per il ruolo dell’Ue nel mondo, anzitutto con il piano Next Generation EU (NGEU). Il suo successo sarà decisivo per il rilancio delle economie degli Stati membri (dimensione interna). Con la parallela emissione di titoli di debito europeo per 750 miliardi di euro, con scadenze fino al 2058, si arriverà anche alla creazione di un safe asset europeo denominato in euro sul mercato internazionale (dimensione esterna). Va da sé che questo scenario sarebbe più debole e improbabile se NGEU non dovesse diventare uno strumento permanente.
Ma la tragedia afghana, che ha reso evidenti sia la volontà degli Stati Uniti di ridimensionare il loro ruolo di “poliziotto globale” sia le criticità della NATO, obbliga gli europei a interrogarsi sulla loro “autonomia strategica” anche nella difesa. Il soft power europeo non basta più, non si può eludere il problema dell’hard power. Si fa finalmente strada l’idea di un “nucleo federale” di difesa europea, di pronto intervento. Ma prima dovrà venire la individuazione di un quadro strategico condiviso e poi quella degli strumenti più idonei per metterli in atto. È quanto i 27 Stati membri stanno cercando di fare con il lavoro sullo Strategic Compass, la definizione di una “bussola strategica” europea, di cui dovremmo conoscere i primi risultati entro fine anno.
Non sarebbe né realistico né auspicabile immaginare una proiezione globale dell’Ue. Pur nel quadro di un duraturo legame transatlantico con gli Stati Uniti (almeno su temi chiave quali ambiente, sicurezza, commercio, digitale), va definita una strategia “sovraregionale”, che guardi ai rapporti a medio termine con la Russia, il Medio Oriente, l’Africa. Verso quest’ultima l’Ue ha una responsabilità speciale, non solo guardando ai fenomeni migratori. Si dovrà puntare a un vero e proprio “partenariato per lo sviluppo” tra Ue e Unione Africana, che prospetti un modello alternativo a quello offerto dal capitalismo autoritario della Cina.
Si tratta di un’agenda impegnativa, con cui l’Unione europea può dare un contributo originale al problema di fondo che abbiamo davanti: come arrivare a un “governo della globalizzazione” nell’attuale disordine globale? È nel nostro interesse di europei provare ad essere lungimiranti e ambiziosi.
*Direttore del Centro Studi sul Federalismo (articolo pubblicato l’11 settembre scorso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nello speciale online “#11 settembre 2001 o la vera fine del ‘900”)


 It
It  En
En