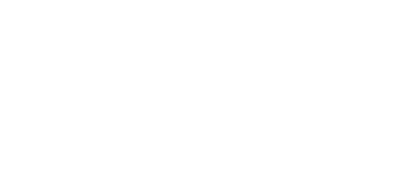Alberto Majocchi / 31 gennaio 2025
Commento n. 312
Poche ore dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che avvia il processo di ritiro degli Stati Uniti da quella che ha definito la “'ingiusta e unilaterale truffa dell'accordo di Parigi sul clima”. Questa decisione, oltre a escludere gli Stati Uniti dalle trattative multilaterali per portare avanti la lotta ai cambiamenti climatici, in vista del raggiungimento della neutralità carbonio per il 2050, rischia di attivare comportamenti analoghi da parte di altri paesi, mettendo così gravemente a rischio l’obiettivo fissato. Si tratta quindi, da un lato, di prendere atto di questa grave decisione americana, coerente con le linee guida della nuova Presidenza Trump, e, d’altro lato, di valutare quali iniziative possano assumere i grandi paesi che emettono in quantità rilevanti anidride carbonica, per reagire in modo efficace alla nuova politica che si è imposta negli Stati Uniti.
Un punto di riferimento per avviare questa valutazione è l’analisi sviluppata da William D. Nordhaus (Premio Nobel per l’Economia 2018) in un celebre articolo pubblicato nel 2015 sull’American Economic Review, in cui osserva come la difficoltà di portare avanti una politica adeguata per combattere i cambiamenti climatici sia legata a un forte incentivo al free-riding implicito negli attuali accordi internazionali sul clima. Il free-riding si verifica quando un paese gode dei benefici legati all’utilizzo di un bene pubblico senza contribuire a sostenerne i costi. In particolare, nel caso dei provvedimenti da assumere al fine di contrastare i cambiamenti climatici, i free riders hanno un incentivo a sfruttare le riduzioni delle emissioni conseguenti a interventi effettuati da altri paesi senza doversi impegnare a sostenere i costi di politiche nazionali per limitare le emissioni. E questo fenomeno spiega la difficoltà di concludere accordi a livello multilaterale, fondati sul consenso unanime degli Stati partecipanti, ad esempio nelle Conference of the Parties (COP) nel quadro della UN Framework Convention on Climate Change.
Nordhaus rileva che molti accordi internazionali sono stati possibili utilizzando il meccanismo dei Club. Il Club è un gruppo formato in modo volontario, i cui componenti traggono benefici dalla condivisione dei costi di produzione di un'attività che ha caratteristiche di bene pubblico. In tal modo, avvantaggia tutti i membri del Club, in misura sufficientemente elevata da indurre i membri a pagare le quote di iscrizione e ad aderire alle regole del Club per goderne i benefici. L'idea di un Climate Club per gestire i cambiamenti climatici potrebbe essere vista come un passo in avanti per avviare a soluzione il problema del free-riding che impedisce la fornitura efficiente di beni pubblici globali.
In termini essenziali, secondo Nordhaus un Climate Club sarebbe un accordo tra i paesi che vi partecipano per intraprendere riduzioni armonizzate delle emissioni. L'accordo si dovrebbe fondare sulla definizione di un "prezzo obiettivo internazionale del carbonio", e questo obiettivo potrebbe essere realizzato utilizzando qualsiasi meccanismo: tassa sul contenuto di carbonio dei combustibili fossili (carbon tax), un sistema di cap-and-trade (Emission Trading System europeo) o altri strumenti, inclusa una regolamentazione che abbia un effetto analogo sul prezzo delle emissioni. Una parte fondamentale del meccanismo del Club ipotizzato da Nordhaus (e la principale differenza rispetto a tutte le proposte già sul campo) è che i non partecipanti dovrebbero essere penalizzati, con l’applicazione di un dazio – con una tariffa percentuale uniforme – che gravi alla frontiera sulle importazioni provenienti da paesi non partecipanti al Club.
In questa proposta di Nordhaus emergono due punti importanti con riferimento alla situazione attuale, conseguente all’uscita dagli Accordi di Parigi annunciata da Trump. In primo luogo, viene qui avanzata una tesi, ripresa successivamente in una Nota del FMI di Ian W.H. Parry, Simon Black e James Roaf, che prevede l’adozione di un price floor per il carbonio decisa in comune fra i Great Emitters di CO2. In questo caso, l’accordo dovrebbe essere raggiunto fra un numero limitato di paesi con l’ammontare più elevato di emissioni. Dopo la decisione di Trump, se si escludono gli Stati Uniti che coprono il 12% del totale delle emissioni, nel 2023 Cina (34%), India (7,6%), Unione europea (6,4%) e Russia (5,3%) rappresentano insieme il 53,3% del totale di emissioni di CO2 a livello globale. Questi paesi potrebbero costituire il nucleo centrale di un Club determinato ad affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, anche utilizzando strumenti differenti e accordandosi su un prezzo del carbonio di un livello tale da poter essere accettato da tutti i membri del Club. La spinta per aderire al Club è legata al fatto che ogni paese potrebbe beneficiare – senza costi ulteriori – degli sforzi per la riduzione delle emissioni da parte degli altri membri del Club.
Il secondo elemento – la penalizzazione dei paesi che non accettano di aderire al Club –, che appare in linea con le minacce di Trump di introdurre dazi sulle importazioni americane dal resto del mondo, è legato alla possibilità di introdurre al livello del Club lo strumento del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), già previsto dall’Unione europea, corrispondente come livello minimo al prezzo del carbonio fissato in comune. L’applicazione del CBAM non dovrebbe considerare solo strumenti di prezzo, ma anche approcci di mitigazione alternativi, che i governi fuori dell’Unione potrebbero preferire per ragioni economiche e sociali diverse. Il Club dovrebbe poi avviare una politica per far entrare nel gruppo altri paesi con elevate emissioni (ad esempio, Giappone, Arabia Saudita, Brasile, Indonesia, Corea del Sud, Canada, Messico), tenendo presente che gli atteggiamenti di questi paesi sono destinati a cambiare profondamente a seguito della politica adottata da Trump.
In definitiva, a fronte del tentativo di Trump di imporre al mondo l’egemonia americana, distruggendo i legami multilaterali costruiti faticosamente nel tempo – a partire dall’abbandono degli Accordi di Parigi sui cambiamenti climatici –, l’Unione europea dovrà assumere una posizione chiara di sostegno degli impegni presi in tema di riduzione delle emissioni, cercando alleanze a partire dai Great Emitters di CO2. Per sostenere questa posizione, l’Unione dovrà rafforzare la propria politica estera, al fine di raccogliere il sostegno non solo delle grandi potenze euro-asiatiche come la Russia e la Cina, ma anche del Sud del mondo, che sarebbe fortemente penalizzato da un fallimento degli accordi per limitare le emissioni e per fronteggiare i rischi dei cambiamenti climatici.
L’Unione, senza rinunciare a priori a mantenere i legami di amicizia e la alleanza strutturale con il paese di oltre-Atlantico, non dovrà mostrare alcun cedimento a fronte dell’arroganza del Presidente americano, ma dovrà rilanciare una rete di accordi a livello globale per restituire la speranza di un futuro dove la cooperazione multilaterale prevalga sulla spinta egemonica della nuova amministrazione degli Stati Uniti. Si tratta di un progetto certamente difficile da realizzare, anche tenendo conto della debolezza attuale dell’Unione, ma che può rappresentare un punto di partenza verso un ordine mondiale meno conflittuale.
*Professore Emerito di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia, membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sul Federalismo

 It
It  En
En