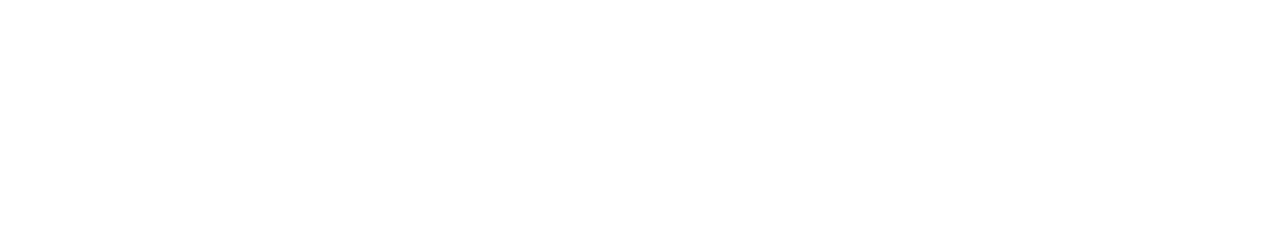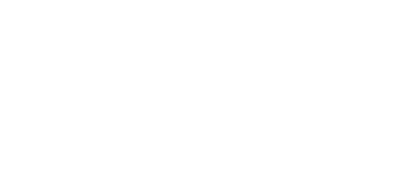Domenico Moro / 20 maggio 2024
Commento n. 296
Il discorso tenuto da Mario Draghi a La Hulpe, il Rapporto Letta e, prima di questi, la proposta della Commissione europea sulla European Defence Industry Strategy, sono la presa d’atto del nuovo ciclo della politica mondiale: il ritorno della politica industriale, se non di una vera e propria forma di “dirigismo” economico, che riguarderà anche l’industria europea della difesa.
Su quest’ultima continuano a circolare tesi fantasiose, che hanno solo parzialmente riscontro con la realtà: la dispersione su più sistemi d’arma rispetto agli USA; il maggior onere sostenuto dagli USA rispetto a quello sostenuto dagli Stati europei; l’assenza di una domanda pubblica europea di sistemi d’arma. Con un quadro del genere, l’avvio di una politica industriale nel settore della difesa può sembrare un compito arduo, ma non è così.
L’impostazione di una politica industriale nel settore della difesa richiede che si individui con la necessaria chiarezza se il problema si pone prioritariamente a livello di domanda o di offerta. Ad esempio, ancora recentemente si è sostenuto che l’UE utilizza 20 velivoli rispetto ai sei degli USA; 17 carri armati al posto di uno solo; 29 fregate al posto di quattro. Si tratta di cifre che, da circa un decennio, si ripetono da un anno all’altro, senza verifiche dei sistemi d’arma cui si fa riferimento. A questo proposito, già a suo tempo era stato proposto di distinguere tra i sistemi d’arma in uso (la cui numerosità pone problemi di interoperabilità e intercambiabilità; problemi e costi di logistica e manutenzione) e sistemi d’arma in produzione (un indicatore del grado di frammentazione industriale). Una verifica più raffinata – ma più complessa – necessiterebbe di un’analisi della struttura di costo delle varie piattaforme, per individuare i costi comuni e i costi specifici di ciascun sistema d’arma e stabilire se si è in presenza di diversi sistemi o di diverse versioni di un unico sistema (ad esempio, l’F-18 Hornet e l’F-18 Super-Hornet sono due velivoli diversi), ma si possono comunque fare considerazioni di carattere generale.
Fatta questa premessa, in base a quelli che il rapporto dell’IISS The Military Balance 2024 considera fighters/ground attack (esclusi i velivoli con prevalente funzione di addestramento), i velivoli in uso negli USA sono sette, di cui tre in produzione, mentre i paesi europei ne utilizzano 14, di cui tre in produzione. Dal punto di vista industriale non vi è, quindi, una maggior frammentazione rispetto agli USA. Piuttosto è frammentata la domanda: dei 14 velivoli utilizzati, più della metà sono extra-europei: cinque USA e quattro ex-URSS. Per quanto riguarda i carri armati (main battle tanks, secondo la nomenclatura di The Military Balance), l’UE ne impiega nove, di cui due in produzione; gli Stati Uniti ne impiegano uno, tuttora in produzione. Anche qui, più della metà di quelli utilizzati dai paesi UE sono extra-europei: due USA e tre ex-URSS. Nel settore navale, i paesi UE (tenuto conto delle comunanze fra tre classi di fregate) impiegano 14 fregate, di cui quattro in costruzione, mentre gli USA ne hanno tre, tutte in corso di costruzione.
Da parte europea vi è sicuramente un eccesso di tipologie di piattaforme militari rispetto agli USA, ma questa dispersione non è tale da rendere lungo e impervio il cammino verso una più spinta razionalizzazione. Inoltre, con lo sviluppo del velivolo franco-tedesco-spagnolo di nuova generazione e del previsto Main Ground Combat System (MGCS) franco-tedesco, l’UE si troverebbe nella stessa situazione degli USA e il sistema industriale europeo si avvicinerebbe ai livelli di efficienza di quello americano.
Lo stesso discorso vale per l’efficacia del sistema difensivo europeo. Da uno studio (del 2018) di Foreign Policy sulla ripartizione delle spese militari USA per area geografica, risulta che il 50% di queste sono dedicate al presidio dell’Indo-Pacifico, il 25% è assegnato al sostegno degli alleati e partners nel Medio Oriente, alla lotta al terrorismo ed alla difesa del territorio americano (comprese le forze strategiche e il sistema missilistico di difesa), il rimanente 25%, vale a dire circa 180 miliardi di euro (2022), alla difesa europea, un cifra molto inferiore ai 298 miliardi spesi dall’UE. Anche ammettendo che per la difesa europea occorra sostenere uno sforzo pari alla somma di quanto vi destinano gli USA e l’UE, quest’ultima, alla luce dei previsti programmi di aumento delle spese militari, potrebbe raggiungere quella cifra nell’arco dei prossimi due-tre anni.
Il vero gap europeo con gli USA, piuttosto, non sta negli investimenti nelle piattaforme militari (nel 2022, 49 miliardi di euro, contro 146 degli USA), bensì negli investimenti in “materia grigia” (RDT&E), dove gli USA investono 113 miliardi di euro, contro i 9,5 dell’UE. Questi investimenti danno agli USA un vantaggio competitivo nel settore militare e in quello civile, come dimostra il fatto che i grandi social network sono nati e si sono consolidati negli USA. Il problema, dunque, come ricordano anche Draghi e Letta, è unicamente di domanda e di un adeguato sostegno alla RDT&E. Fino a quando non vi sarà una domanda pubblica europea le società europee dovranno accontentarsi della faticosa, e fin qui infruttifera, strada della cooperazione intergovernativa: in sostanza, della buona volontà dei governi.
Una domanda pubblica europea – che non dovrà sostituire integralmente la domanda nazionale – è indispensabile non solo per promuovere l’acquisto di piattaforme militari interoperabili, ma per dare la direzione di marcia ai sistemi industriali nazionali. Essa dovrà però essere promossa da un’adeguata struttura militare di pianificazione, comando e controllo – fondata su personale assunto direttamente dall’UE e non distaccato dagli Stati nazionali – e alimentata da autonome forze armate europee.
Dal punto di vista della domanda pubblica europea, non si parte da zero, per due ragioni. La prima è data dal precedente degli investimenti nell’infrastruttura spaziale, dove l’UE, avvalendosi dell’art. 187 TFUE, ha promosso la realizzazione delle reti satellitari Galileo e Copernico, di cui – va sottolineato – è proprietaria ed ora sta lanciando il nuovo sistema satellitare di comunicazioni criptate Iris. Si tratta di tecnologie duali, vale a dire civili-militari, e i cambiamenti in corso nella politica di finanziamento della BEI aprono la strada all’acquisto di prodotti con un più marcato profilo militare. In secondo luogo, come è stato ben messo in luce recentemente, il Regolamento ASAP (Act in Support of Ammunition Production) del 2023 può costituire un precedente per futuri acquisti non di sole munizioni ma di vere e proprie piattaforme militari da parte dell’UE. Per fare un esempio, esso potrebbe aprire la strada all’acquisto, da parte europea, di velivoli e carri armati ereditati dall’ex-URSS e in dotazione dei paesi dell’Est europeo. La loro sostituzione con piattaforme militari europee consentirebbe di ridurre in misura significativa – circa un terzo –, il numero di piattaforme di cui sono dotati i paesi UE.
L’ostacolo più serio all’avvio di una politica industriale europea in questo settore è piuttosto quello delle risorse finanziarie: solo l’emissione di eurobond consentirebbe di raccogliere risorse per la difesa, in un breve arco temporale. Si tratta di un passaggio ineludibile, che darebbe all’UE una leva decisiva per promuovere una politica industriale europea: nei bilanci pubblici nazionali non vi sono, infatti, spazi fiscali in grado di sostenere le necessarie spese per la difesa.
*Membro del Consiglio Direttivo e Coordinatore dell’Area Sicurezza e Difesa del Centro Studi sul Federalismo
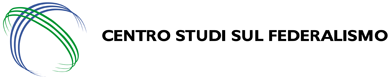

 It
It  En
En