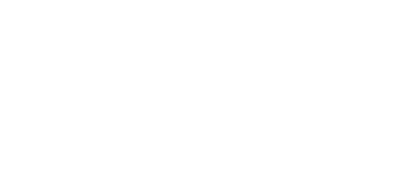Alberto Majocchi / 25 giugno 2024
Commento n. 301
L’impatto dei cambiamenti climatici diventa sempre più grave. Nel 2022 le emissioni globali di CO2 nell’atmosfera hanno continuato a crescere e sono risultate pari a 53,8 miliardi di tonnellate, con un incremento dell’1,4% rispetto al 2021. I sei Big Emitters (Cina, Stati Uniti, India, Unione europea, Russia, Brasile) hanno contribuito per il 61,6% di quell’ammontare. All’interno di tale gruppo, dal 1990 al 2021 le emissioni dell’Unione europea si sono ridotte del 27%, quelle della Russia del 15,5% e degli Stati Uniti del 2,4%, mentre in Cina sono aumentate nello stesso periodo di tempo del 285% e in India del 170%.
Questi dati sintetici mostrano il ruolo delle due grandi potenze emergenti del continente asiatico nell’accelerazione del problema. Ma il punto da sottolineare è che occorre considerare non solo l’evoluzione passata, ma anche la prevedibile evoluzione futura. E in questa prospettiva la Cina, che nel dibattito corrente viene indicata come la principale responsabile nell’aggravamento della crisi climatica, mostra notevoli potenzialità di miglioramento nel settore energetico, che gioca un ruolo decisivo per il controllo delle emissioni di CO2.
L’International Energy Agency (IEA), nel World Energy Outlook del 2023, sottolinea come il governo cinese preveda di arrivare al picco delle emissioni nel 2030, con l’obiettivo di emissioni zero nel 2060 e con un obiettivo intermedio rappresentato da un consumo di energia di origine non fossile pari al 20% nel 2025. Le difficoltà da affrontare per raggiungere quel risultato sono enormi, in quanto le emissioni totali di CO2 in Cina ammontano a 15,7 miliardi di tonnellate (pari a circa 11 tonn. pro capite), e rappresentano il 29,1% delle emissioni mondiali. Inoltre, il carbone fornisce ancora il 60% del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica.
La sfida viene affrontata dal governo cinese con una previsione di investimenti annuali che arriverà a 640 miliardi di dollari nel 2030. Il solare, utilizzato per la produzione di energia e per il riscaldamento, diventerà la più grande risorsa di energia primaria entro il 2045 e pari a circa un quarto della domanda nel 2060. La quota di energia a bassa emissione di carbonio – solare, eolica, idroelettrica, bioenergia, altre rinnovabili ed energia nucleare – nella domanda primaria di energia passerà dall’attuale 15% al 74% nel 2060, mentre la produzione alimentata da carbone dovrebbe scendere al 5%. Dopo il 2030, la carbon capture and storage (CCS) per stoccare il carbonio emesso con l’impiego del carbone aumenterà progressivamente e la produzione di elettricità con utilizzo del carbone quale fonte di energia senza stoccaggio del carbonio cesserà nel 2050.
La Cina, data la sua collocazione negli equilibri globali, presta particolare attenzione alla cooperazione con il Sud del mondo e da tempo ha istituito un Fondo di Cooperazione Sud-Sud sui cambiamenti climatici, con un investimento da parte del governo cinese di 20 miliardi di yuan (3,1 miliardi di dollari). Ha lo scopo di “sostenere altri paesi in via di sviluppo nell’affrontare il cambiamento climatico e nella transizione verso un’economia verde e a basse emissioni di carbonio.”.
Per quanto riguarda l’Europa, dopo l’approvazione del Green Deal, un’importanza primaria nel far avanzare la lotta ai cambiamenti climatici riveste l’adozione della Climate Law, con l’obiettivo intermedio, giuridicamente vincolante, di una riduzione del 55% delle emissioni di CO2 nel 2030, per raggiungere la neutralità carbonio nel 2050. Con l’approvazione da parte del Consiglio del pacchetto Fit for 55, è stato istituito un nuovo sistema separato di scambio dei permessi di emissioni per gli edifici, i trasporti stradali e altri settori (soprattutto la piccola industria). A partire dal 2027, il nuovo sistema imporrà l’acquisto di permessi ai produttori e agli importatori che forniscono combustibili all’edilizia, all’autotrasporto e ad altri settori (upstream approach).
L’obbligo di acquisto di permessi di emissione verrà gradualmente esteso al settore marittimo, mentre la concessione di permessi gratuiti agli operatori del settore aereo verrà progressivamente ridotta. Infine, a partire dal 1º ottobre 2023, il regolamento (UE) 2023/956 ha introdotto il meccanismo di aggiustamento fiscale alle frontiere dell’Unione (Carbon Border Adjustment Mechanism), con l'obiettivo di far pagare un prezzo per le emissioni durante la produzione di merci a elevata intensità di carbonio importate nell’Unione e di evitare una perdita di competitività della produzione verde europea nei confronti di paesi con politiche ambientali meno ambiziose.
Ma per raggiungere gli obiettivi fissati dagli Accordi di Parigi del 2015 l’impegno europeo – che dovrà essere confermato nella legislatura che si apre e che, in ogni caso, rappresenta uno stimolo per gli altri paesi a adottare interventi adeguati – non è sufficiente, perché il problema dei cambiamenti climatici è di natura globale. Nel 2021, una Nota del Fondo Monetario Internazionale proponeva un accordo fra i Big Emitters di CO2 al fine di fissare un prezzo minimo per il carbonio. Data la difficoltà – per l’elevatissimo numero di paesi coinvolti – di raggiungere accordi all’unanimità nell’ambito delle COP (Conference of Parties) promosse annualmente dalle Nazioni Unite, un’ipotesi simile potrebbe essere rilanciata dall’Unione, con l’obiettivo di costituire un gruppo ristretto di paesi impegnati a preparare il terreno per decisioni vincolanti a livello globale. Decisioni da assumere poi nell’ambito delle COP, tenendo presente, come ricordato all’inizio, che i sei Big Emitters (Cina, Usa, India, Ue, Russia, Brasile) insieme contribuiscono per il 61,6% al totale delle emissioni. In questa prospettiva, l’evoluzione della politica cinese in tema di controllo dei cambiamenti climatici può rappresentare un esempio utile per coinvolgere i paesi del Global South nel raggiungimento dell’obiettivo della decarbonizzazione.
*Professore Emerito di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia, membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sul Federalismo

 It
It  En
En