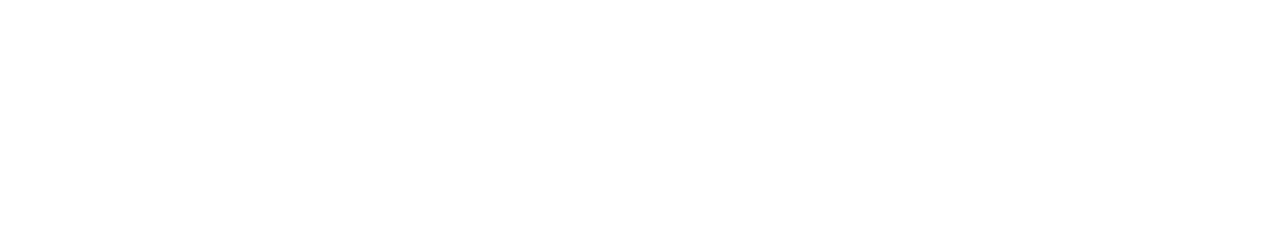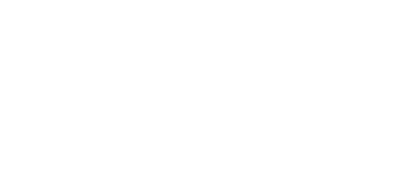Antonio Padoa Schioppa / 4 giugno 2024
Commento n. 298
Quanti in Europa propugnano una destrutturazione dell’Unione attuale in favore di un recupero di sovranità nazionali appartengono a due diverse correnti di pensiero. La prima fa leva su un’ingenua e irrealistica aspirazione a un ritorno alla sola sovranità nazionale, una tesi dotata tuttora di una quota importante di consensi popolari da parte di chi è poco informato, sfruttata anche per questo a fini elettorali dai partiti e dai movimenti della destra sovranista. La seconda tendenza – spesso condivisa tacitamente dalle stesse forze politiche di destra, ma anche da partiti o da correnti interne ai partiti che si dichiarano per "più Europa" – è mossa dalla convinzione, dichiarata o meno, che l’Unione europea (Ue) sarà comunque dominata da Francia e Germania, o anche da uno solo di questi due Paesi, e che sia pertanto preferibile una sostanziale dipendenza degli Stati europei dagli Stati Uniti, potenza egemone anche militarmente attraverso la Nato, non solo più affidabile sul piano del potere ma meno prossima e pertanto ritenuta meno oppressiva.
La prima posizione è agevolmente confutabile se solo si considerano le forze economiche e politiche in campo nel mondo globale di oggi. Ed è ormai altrettanto chiaro – per chi lo vuol capire – che la costruzione di un’Europa più unita e coesa non contrasta minimamente con il mantenimento di un’identità nazionale: le diverse identità – municipale, regionale, nazionale, europea, planetaria – possono e debbono coesistere, ognuna al proprio livello nell’ottica della sussidiarietà.
La seconda posizione antieuropea non è meno infondata, per due ordini di motivi. In primo luogo, si può dimostrare che là dove l’Unione è più avanzata istituzionalmente ed economicamente – con una legislazione basata sulla cooperazione tra Commissione, Parlamento europeo e Consigli deliberanti a maggioranza, ma altrettanto vale per la politica monetaria gestita dalla Banca centrale europea, in cui si decide a maggioranza – è proprio tale configurazione istituzionale ad impedire egemonie stabili e irreversibili di un solo Paese ed anche di più Paesi, anche se è innegabile che difficilmente una politica avversata sia dalla Francia sia dalla Germania possa ottenere la maggioranza qualificata necessaria al suo varo. Ciò che ancora manca è l’adozione di procedure di stampo federale e democratico, già presenti per molti ambiti, nei settori e per le decisioni in cui l’Ue a oggi ne è priva, dalla politica estera, alla difesa comune, alla fiscalità europea: occorrono anche qui le due Camere degli Stati e del popolo co-deliberanti, un Parlamento eletto, un governo efficace, una Corte di giustizia, un potere fiscale europeo.
In secondo luogo, si dimentica che anche nei confronti tra Europa e Stati Uniti vale l’eterna legge dei rapporti di potere tra Stati, per la quale uno Stato, tanto più se potente, punta anzitutto al proprio vero o supposto interesse nazionale. E questo non sempre coincide, per gli Stati Uniti, con gli interessi dell’Europa come tale, là dove questi interessi siano evidenti e condivisi. La ragion di stato degli Stati Uniti può non coincidere con la ragione di stato dell’Europa nella politica internazionale, nella politica economica, nella politica monetaria dominata dal dollaro. Ciò è accaduto più volte in passato e sarà vero sempre in più settori della politica e dell’economia: per il Medio Oriente, per i rapporti con la Russia e con la Cina, per le fonti di energia, per il commercio, per i rapporti con l’Africa e con l’America latina. E allora appare chiaro come una struttura definita e compatta dell’Unione europea, che in parte già esiste (nella moneta, nel commercio, nella concorrenza e altro), sia nell’interesse comune dei nostri Paesi, i quali se dipenderanno sempre politicamente e militarmente dagli Usa avranno ben poca voce in capitolo.
A questo fine, anche una difesa comune europea appare indispensabile; ed è significativo che, in base a ripetuti sondaggi, il 70% degli europei condivida questo obiettivo. Il che non significa affatto negare l’importanza dell’Alleanza atlantica o tantomeno volerla abolire, ma semplicemente voler rivendicare un’autonomia che oggi nessun Paese europeo possiede e che solo un’unione matura potrà garantire; come anche una parte, pur minoritaria, della classe politica statunitense ha sempre riconosciuto, dal tempo della formula kennediana di una equal partnership con l’Europa. L’Ue dovrebbe in pari tempo, proprio perché capace di difendersi autonomamente, riprendere la linea del progressivo disarmo controllato e delle verifiche trasparenti e monitorate.
A chi argomenta, sulla base di un realismo considerato inoppugnabile, che è comunque sempre prevalsa nella storia la ragion di stato del più forte, e oggi nella fattispecie la prevalenza degli Usa sull’Europa – è questa la tesi brillantemente difesa da Manlio Graziano nella sua recente, lucida monografia Disordine mondiale – si può obiettare che questo non è stato sempre vero. La storia mostra che posizioni assolutamente minoritarie, sostenute inizialmente solo da pochi pensatori idealisti contro un formidabile ordine costituito – dal suffragio popolare alla libertà di stampa, dalla libertà di coscienza alla posizione sociale della donna, dai diritti del lavoratore alla progressività delle imposte e altro ancora – si sono poi affermate. E si deve riconoscere che anche nei confronti della politica statunitense – ad esempio in tema di moneta europea, di commercio internazionale, di poteri delle grandi corporations, di armamenti progettati in Europa, di satelliti europei, di tecnologie avanzate e altro – gli interessi divergenti dell’Ue in più occasioni sono prevalsi. Ma solo là dove l’assetto istituzionale dell’Unione lo ha reso possibile.
C’è inoltre un ulteriore elemento da considerare. In un mondo di crisi globali – dal clima all’ambiente, dalla biodiversità minacciata alla guerra nucleare, dalla fusione delle calotte polari alle pandemie – è evidente che i rimedi non possano essere se non globali. Il che presuppone una cooperazione tra Stati, anche caratterizzati da regimi profondamente diversi e da interessi politici ed economici altrettanto diversi e conflittuali. E allora non solo la cooperazione internazionale e multilaterale è indispensabile, non certo l’egemonia di uno o due o tre Stati potenza, ma altrettanto indispensabile è l’accettazione di settori nei quali sia effettivamente operante un potere superiore agli Stati, tale da imporre in concreto obblighi altrimenti eludibili ed elusi. E qui gli Stati Uniti – cui pure risale il varo dell’Onu nel 1945 e successivamente di altre istituzionali internazionali – hanno purtroppo dimostrato negli ultimi anni una renitenza crescente: dal WTO alla Corte penale internazionale, dall’esercizio del potere di veto in seno al Consiglio di Sicurezza (peraltro condiviso da Russia e Cina) e altro ancora. Proprio l’Europa, se e quando completata nel suo progetto d’Unione, potrebbe fare la differenza, creando legami in chiave cosmopolitica – dimensione ben presente nel progetto europeo sin dal Manifesto di Ventotene – e promuovendo l’adesione di chi si mostri disponibile a condividerla.
Il vero discrimine tra chi chiede più Europa – anche con accenti e motivazioni differenti – e chi invoca meno Europa sta in queste alternative. E l’elezione europea a suffragio universale è la sede nella quale tale discrimine è stato evidente in passato e lo sarà nel prossimo futuro.
*Professore emerito dell’Università degli Studi di Milano e membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sul Federalismo (di cui è stato Presidente dal 2004 al 2010).
Download PDF - Commento n. 298
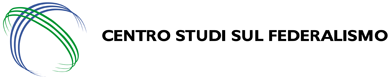

 It
It  En
En