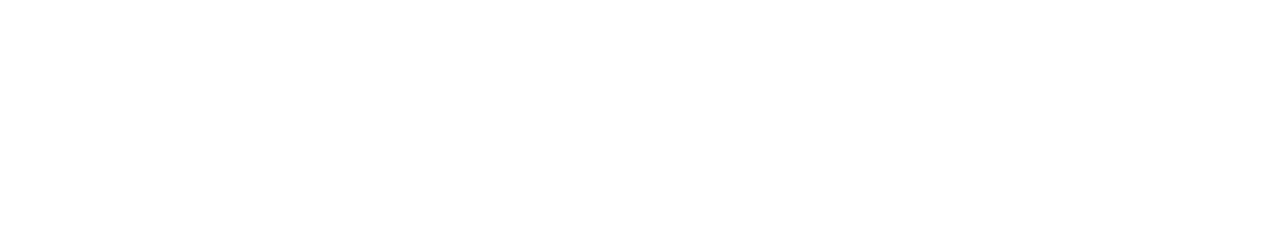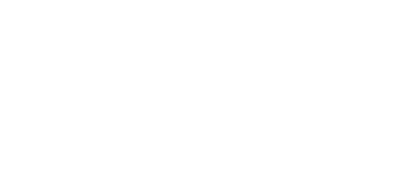Robero Palea
Commento n. 175 - 10 aprile 2020
Nel marzo 2015, Bill Gates, impegnato principalmente sul fronte dei problemi sanitari in Africa con la sua Fondazione Bill e Melinda Gates, tenne una conferenza a Vancouver (uno dei cosiddetti Ted Talks), in cui evidenziava che il rischio più grave di catastrofe globale che doveva temere l’umanità, più che quello di una guerra nucleare, era quello di “un virus altamente contagioso, capace di uccidere 10 milioni di persone”.
Bill Gates proponeva una serie di iniziative, basate sul rafforzamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel settore della ricerca scientifica (la più preziosa risorsa del nostro tempo) ed in quello della capacità di intervento rapido di team di medici ed infermieri specializzati, eventualmente supportati da militari, in grado di attuare misure di contenimento dell’epidemia e di applicare, in loco, le prime terapie per mettere in sicurezza l’area coinvolta.
La Banca Mondiale, all’epoca, stimò che un’epidemia virale mondiale avrebbe provocato danni per tre trilioni di dollari e milioni di morti. D’altronde nel 1918 l’influenza “spagnola” produsse ben 30 milioni di decessi, in tutto il mondo.
La lezione di Bill Gates venne ben presto dimenticata, anche perché l’epidemia del virus Ebola, di cui lui si stava allora occupando, venne contenuta, in quanto non trasmissibile per via aerea, e nonostante i campanelli d’allarme legati ad altre pandemie quali Hiv, Sars e Mers.
Ora, il mondo si confronta, ampiamente impreparato, con la pandemia del Covid-19. Un virus che si trasmette per via aerea in un mondo sempre più interconnesso ed è particolarmente aggressivo, non di rado letale soprattutto per le categorie più deboli della popolazione, dagli anziani ai malati affetti da altre patologie. Nonostante gli sforzi in atto, a livello mondiale, non è stata ancora individuata una terapia medica efficace né è alle viste un vaccino sperimentato, il cui impiego, nell’ipotesi più favorevole, potrà intervenire, solo nel corso del 2021.
L’unico provvedimento adottato da tutti i Paesi interessati dalla pandemia, con modalità e tempi differenti, è stato quello del “confinamento sociale” dei cittadini, sospendendo per mesi ogni attività produttiva e commerciale, salvo che nei settori indispensabili dell’agricoltura, del commercio di prodotti alimentari, dei trasporti necessari di persone e di cose, e nel settore sanitario, con gravissimi danni economici e finanziari per le imprese e per milioni di occupati.
La pandemia del Covid-19 si interseca con il problema del riscaldamento climatico e del degrado dell’ambiente naturale, poiché anch’essa è un risultato di un Pianeta portato all’estremo delle sue capacità, con la progressiva distruzione degli ecosistemi e della loro capacità equilibratrice, ad opera dell’uomo. Con il disboscamento delle foreste, soprattutto tropicali, l’avanzata della desertificazione dei suoli, la cementificazione dei terreni, l’uomo ha sottratto l’habitat agli animali che ospitano virus e batteri, spingendoli sempre più vicini agli agglomerati urbani, nel cui contesto diventa possibile il “salto di specie” da cui derivano le malattie pandemiche. Queste, grazie alla globalizzazione, si propagano rapidamente nel mondo intero.
Va poi ricordato che la naturale, principale difesa dell’organismo umano verso elementi patogeni è rappresentata dal nostro sistema immunitario. Questo è gravemente minacciato da stili di vita malsani, dall’abuso di farmaci, dalle pessime condizioni ambientali e dall’inquinamento atmosferico che attanaglia metropoli abitate da milioni di persone.
La pandemia da Covid-19 non è che una delle possibili conseguenze, finora manifestatesi solo con effetti locali (il caldo estivo in Francia nel 2003 e in Russia nel 2010, che provocarono molte migliaia di morti, gli uragani Katrina nel 2005 o Maria nel 2017, i grandi incendi in Australia), che il riscaldamento globale ed il degrado ambientale possono provocare, mano a mano che il Mondo si allontana, purtroppo, dagli obiettivi del Trattato sul Clima di Parigi del 2015.
L’UE che si è posta l’obiettivo di fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero, riducendo le emissioni di carbonio nell’atmosfera del 55% entro il 2030, si trova ora a confrontarsi, simultaneamente, con il generale problema della riconversione ecologica dell’economia e, di fatto, con una manifestazione in campo sanitario di quell’obiettivo fondamentale che la Commissione Von der Leyen si è impegnata a perseguire.
Il gravoso compito di affrontare simultaneamente le due emergenze (l’una ad effetto immediato, l’altra con effetto più differito) comporta il massimo della responsabilità nelle Istituzioni europee ed uno sforzo finanziario straordinario. Le conseguenze economico-finanziarie della pandemia e gli aiuti a favore dei Paesi più colpiti richiederanno il ricorso ad ogni strumento a disposizione, tenendo presenti i principi fondamentali dei Trattati dell’UE, tra i quali quello della solidarietà tra gli Stati membri.
Ma, come si è detto, l’UE deve anche affrontare la seconda emergenza, quella del lancio di un poderoso Piano per il Green Deal europeo che, a mio avviso, richiederà un consistente aumento del Bilancio Pluriennale dell’Unione, basato su adeguate risorse proprie, piuttosto che su contributi degli Stati, come lo stesso Trattato sull’UE impone.
Il Centro Studi sul Federalismo ha fornito indicazioni precise per quanto riguarda il Border Tax Adjustment nel settore energetico; cui naturalmente si collegherebbe un adeguato carbon pricing nel suddetto settore per evitare distorsioni sul mercato interno dei carburanti. Andrebbero, poi, istituite una adeguata Digital Tax ed una Tassa sulle Transazioni Finanziarie. Sarebbe, infine, necessario porre termine allo scorretto dumping fiscale tra gli Stati membri, che consente ad alcuni di essi (Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Cipro, Malta) di attirare nel loro Paese la sede legale delle società multinazionali, concedendo tassazioni fortemente agevolate, rispetto alla media delle aliquote sui redditi delle imprese in vigore negli altri Stati europei.
Mi pare opportuno ricordare che quando Franklin Delano Roosevelt si insediò alla Presidenza degli Stati Uniti si trovò in una situazione analoga, per la concorrenza fiscale, al ribasso, tra gli Stati federati di Florida, Texas ed Arkansas. Egli, nel 1932, decise di porre fine a quelle pratiche scorrette, istituendo una Tassa Federale sui redditi delle imprese, con un’unica aliquota, che gli consentì di regolare il problema nell’arco di sei mesi.
*Già Presidente del Centro Studi sul Federalismo, membro dell’Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali (AIEAR)


 It
It  En
En