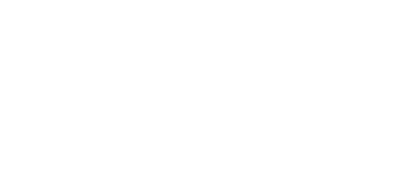Federico Fabbrini / 3 febbraio 2025
Commento n. 313
Un antico detto afferma che per chi ha in mano un martello, ogni problema si manifesta in forma di chiodo. L’unico martello di cui oggi dispone l’Unione europea (UE) si chiama “regolazione”. E dunque è a colpi di leggi e regolamenti che l’UE propone di affrontare anche il problema della competitività economica del vecchio continente.
Questo, potrebbe dirsi in sintesi, è il succo della comunicazione della Commissione europea sulla “Bussola europea per la competitività” (Competitiveness Compass), pubblicata il 29 gennaio. Tale comunicazione, che viene presentata come lo strumento che “will frame the work of the Commission for its entire mandate [inquadrerà il lavoro della Commissione per il suo intero mandato]” quinquennale, è la risposta da parte dell’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen ai due importanti rapporti sull’approfondimento del mercato interno e sul futuro dell’economia europea preparati dagli ex Presidenti del Consiglio italiani Enrico Letta e Mario Draghi, e presentati rispettivamente nell’aprile e settembre 2024.
Rispetto ai due rapporti, tuttavia, la Bussola sulla competitività europea è un documento molto più scarno, di appena 26 pagine, il cui intento è delineare un’agenda per la Commissione europea nei mesi e anni a venire. Il documento è diviso in tre grandi capitoli sostanziali, che corrispondono alle tre aree che la Commissione identifica come destinatarie dei suoi futuri interventi principali, ovvero: 1) iniziative per colmare il gap nell’innovazione; 2) misure che favoriscano la decarbonizzazione pur salvaguardando la competitività dell’industria; e 3) azioni per ridurre la dipendenza eccessiva e aumentare la sicurezza economica europea. A questi obiettivi si aggiungono ulteriori interventi orizzontali, descritti nell’ultimo capitolo della comunicazione, dove la Commissione si promette di promuovere misure di semplificazione amministrativa, di approfondimento del mercato interno, di realizzazione di un’unione dei risparmi e degli investimenti e di un’unione per la promozione dell’apprendimento – al fine di creare un ecosistema più favorevole alla competitività.
Nella sostanza, le misure identificate dalla Commissione europea nella sua Bussola sulla competitività – un termine che volutamente richiama la Bussola strategica sulla politica estera e di sicurezza comune, approvata nella primavera 2022 in risposta alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina – non sono dirompenti. Al contrario, la comunicazione ripete obiettivi che sono già stati convincentemente indicati nei rapporti Letta e Draghi come necessari ad assicurare la crescita economica dell’UE nel futuro prossimo. Tra questi, vi è l’intenzione di investire sui nuovi driver dell’innovazione, in particolare quella tecnologica, di rafforzare le reti digitali, di ridurre il prezzo dell’energia, di promuovere l’economia circolare, di diversificare i legami commerciali e di rafforzare la sicurezza economica. In questa prospettiva, peraltro, la Bussola richiama anche l’invito del rapporto scritto dall’ex Presidente finlandese Sauli Niinistö ad aumentare la preparazione dell’UE alle minacce esterne, sia di tipo politico-militare che economico e sanitario.
Tuttavia, per raggiungere i suddetti obiettivi, la comunicazione sulla Bussola per la competitività elenca una lista di atti legislativi che la Commissione europea intende presentare e fare approvare a ritmi serrati nei prossimi mesi e anni. Tra le molte proposte, nello specifico, la Bussola prevede l’adozione di una legge europea sull’innovazione, di una legge europea sul cloud e sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale, di una legge europea sui materiali avanzati, di una legge europea sullo spazio, di una legge europea sui network digitali, di una legge europea sull’accelerazione della decarbonizzazione industriale, di una legge europea sull’economia circolare, di una legge europea sui medicinali critici. A tutto ciò si aggiungono almeno una dozzina di strategie e piani d’azioni per i campi più vari, dall’acciaio all’industria chimica, dai porti all’industria marittima, dall’automotive all’agricoltura, dalla difesa all’adattamento climatico etc.
Naturalmente, le iniziative della Commissione sono lodevoli, ma si può dubitare che l’innovazione dell’economia europea possa essere raggiunta per legge. Anzi, la Bussola sulla competitività finisce per contraddire sé stessa: nonostante uno degli obiettivi della Commissione sia semplificare il quadro regolatorio e ridurre il peso della compliance amministrativa, in realtà la comunicazione preannuncia l’adozione di ancora più norme, che andranno ad aggiungersi a tutte quelle già adottate nell’ultimo quinquennio (oltre 13.500, secondo quanto affermato dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini al Sole 24 Ore, il 1° febbraio scorso). Ma come si è ricordato all’inizio, quando uno ha in mano un martello, ogni problema è un chiodo, e se il martello è il potere regolatorio, allora il chiodo si affronta con nuove regole.
L’aspetto dove la Bussola sulla competitività è ampiamente lacunoso, invece, è quello relativo al finanziamento della competitività europea. Nonostante i proclami di creare un’unione dei risparmi e degli investimenti – che poi rischia di essere un rebranding dell’unione dei mercati dei capitali, in discussione da un decennio e mai realizzata a causa di opposizioni politiche – la comunicazione è assai timida nel discutere quali finanziamenti pubblici saranno messi a disposizione per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e trasformazione digitale. Qui la comunicazione si limita a dire che bisognerà ricalibrare il bilancio comunitario, che però sarà rivisto solo nel 2027, e a citare i beni pubblici europei, senza mai dire come si debbano finanziare. Anzi, nell’assenza di disponibilità finanziarie comuni a livello europeo, la comunicazione prevede di allargare i margini per la concessione di aiuti di stato tramite i bilanci nazionali: di nuovo una misura contraddittoria, in quanto contraria al fine della Bussola di rafforzare il level playing field alla base del mercato interno dell’UE.
La timidezza della Commissione nel preannunciare misure fiscali di supporto alla competitività è però comprensibile, visto che l’UE dispone di un’irrisoria capacità fiscale, la cui mobilitazione è sottoposta a lacci e lacciuoli. Se però si vuole davvero rendere l’UE più competitiva, non sarebbe il caso di dare alle istituzioni europee un nuovo martello, diverso dalla regolazione, per affrontare le drammatiche sfide economiche che affronta? Il martello regolatorio della Commissione può sembrare perverso, ma finché gli Stati non daranno all’UE una vera potestà fiscale per piantare i chiodi nei muri continueremo a usare le leggi.
*Professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso la Dublin City University e Direttore fondatore del Dublin European Law Institute

 It
It  En
En