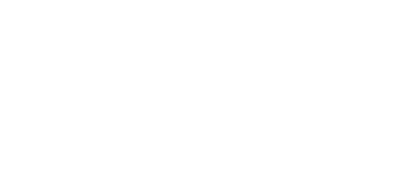Domenico Moro / 29 gennaio 2025
Commento n. 311
Ogni volta che si parla della necessità di dotare l’Unione europea (UE) di un’autonoma capacità militare, ci si trova di fronte a due obiezioni: a) non ci può essere una difesa senza una politica estera europea; b) non sarebbe chiaro a quale istituzione farebbe capo un esercito europeo. Una impostazione autorevolmente sostenuta anche nel dibattito sulla posizione dell’Italia in vista del Consiglio europeo del dicembre scorso, presentata al Parlamento italiano dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Se si collegano difesa e politica estera, fino a subordinare la realizzazione della prima alla seconda, è molto probabile che non si faranno né l’una né l’altra. Con il ritorno della guerra in Europa bisogna piuttosto tenere presente l’insegnamento di Jean Monnet sul modo in cui uscire da un’impasse politica: “avevo imparato – sosteneva Monnet (nella sua autobiografia Cittadino d’Europa) – che non si può agire su linee generali, partendo da un concetto vago, ma che tutto diventa possibile se si riesce a concentrarsi su un punto preciso che determina poi tutto il resto”. L’istituzione di un’autonoma forza europea di difesa oggi è il punto su cui agire.
Quando una comunità politica viene aggredita o è minacciata da un’aggressione, non vi è alcuna decisione di politica estera da prendere: si deve organizzare la difesa. La difesa dei confini orientali dell’UE non richiede nessuna decisione di politica estera. Tutti i paesi dell’UE, tranne forse Ungheria e Slovacchia, sono d’accordo sul fatto che l’UE si debba dotare di una difesa autonoma. La decisione può avvenire a trattati vigenti, ricorrendo allo strumento della cooperazione strutturata permanente (art. 42.6 TUE), secondo cui si può decidere, a maggioranza qualificata, che un’avanguardia di paesi proceda all’istituzione di una forza multinazionale permanente (art. 1.b, Protocollo 10). Questa forza multinazionale integrerà le forze militari nazionali a presidio dei confini orientali e, in tutto o in parte, la forza di interposizione tra Ucraina e Russia, una volta raggiunto l’accordo per una tregua.
Il legame con la politica estera non si pone con riferimento al primo nucleo di una difesa europea, ma si porrà quando di tratterà di ricorrere all’uso delle forze armate in operazioni condotte al di fuori dei confini UE. Questa è la situazione in cui la forza militare diventa uno strumento al servizio della politica estera. Già oggi l’UE conduce 13 missioni civili e 10 missioni militari all’estero. Queste ultime sono condotte a seguito della richiesta delle Nazioni Unite, o dei paesi interessati. Soltanto la missione Aspide, nel Mar Rosso e nell’Oceano indiano, è una missione decisa dalla sola UE. Nella conduzione della maggior parte di queste missioni, potrebbe benissimo subentrare la forza multinazionale europea.
A chi farebbe riferimento la forza multinazionale europea? La risposta si trova se si prende atto dei passi avanti compiuti dall’UE nel settore della difesa. A seguito del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, l’UE si è progressivamente dotata della stessa struttura di cui è dotato il Patto Atlantico: un Comitato politico, un Comitato militare e uno Stato maggiore. Rispetto al Patto Atlantico, vi è il Parlamento europeo eletto, il quale vota la Commissione europea e il suo vicepresidente, che è anche Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR). Nei sistemi federali, come la Repubblica federale tedesca, le forze armate fanno capo al ministero della difesa; nel caso dell’UE, la forza multinazionale potrebbe fare capo all’AR, il quale risponde sia al Consiglio europeo sia alla Commissione e, quindi, anche al Parlamento europeo.
Trattandosi di un’avanguardia di paesi che mette a disposizione dell’UE – in permanenza – una parte delle proprie forze armate, questa parte diventa un vero e proprio asset europeo, che fornisce un bene pubblico europeo e che dovrà essere finanziato dall’UE, in base a due possibili vie. La prima è quella di prevedere una linea di bilancio specifica all’interno del bilancio UE; l’altra è quella di emettere un bond europeo per la difesa, suddividendo una parte degli introiti tra le forze armate nazionali e quella europea. Il servizio del debito dovrà essere coperto dall’aumento delle risorse proprie.
Fare la difesa europea non è un compito semplice e le difficoltà non sono solo a livello politico, ma anche di opinione pubblica, in quanto si sono storicamente consolidate attorno a un unico modello istituzionale – lo Stato unitario –, per cui ci si aspetta che a livello europeo vi sia un unico esercito al posto di ventisette eserciti nazionali. Si è già avuto modo di contestare questa prospettiva, sostenendo che la difesa europea si farà solo se sarà una difesa federale, adottando il modello di difesa degli Stati Uniti dove, per più di un secolo a partire dalla loro fondazione, accanto alle forze armate federali vi erano (e vi sono tuttora) le milizie statali (oggi Guardia nazionale).
In un mondo fortemente interconnesso, la politica estera non si riduce ai rapporti diplomatici (dove l’UE è ancora divisa) e all’uso della forza (di cui l’UE non è ancora dotata). La forza militare, piuttosto, si aggiungerà agli elementi di potere di cui l’UE è già attrezzata. Nell’esercizio della competenza esclusiva nel commercio con l’estero, gli accordi con il Canada e i paesi del Mercosur riducono l’influenza USA in quelle aree geografiche. L’euro contende al dollaro e ad altre valute il ruolo di valuta di riferimento negli scambi commerciali e consente all’UE (se si realizzerà in tempi rapidi l’Unione dei Risparmi e degli Investimenti che la Commissione europea lancia oggi) di competere con gli USA per il controllo del risparmio generato dalle due comunità politiche. La stessa cosa vale per la competenza esclusiva nel settore della concorrenza, quando l’UE adotta misure per contrastare il monopolio delle grandi società high-tech. Il titolo di questo Commento, quindi, non è del tutto corretto, in quanto l’UE fa già politica estera, sia pure con mezzi diversi dalla forza.
È indubbio che una Unione dotata di un’autonoma forza militare, per questo solo fatto, diventa un attore più credibile su scala mondiale e ne modifica gli equilibri di potere. Dotarla di una forza armata, ed essendo l’unica comunità politica che ha interesse a sostenere un mondo basato su regole condivise, le consentirà di promuovere una politica volta al rafforzamento delle istituzioni multilaterali e, come accade già oggi, di impiegare con maggior efficacia la sua forza militare per operazioni condotte al di fuori dei confini UE, su richiesta delle Nazioni Unite o delle organizzazioni regionali.
*Membro del Consiglio Direttivo e Coordinatore dell’Area Sicurezza e Difesa del Centro Studi sul Federalismo

 It
It  En
En