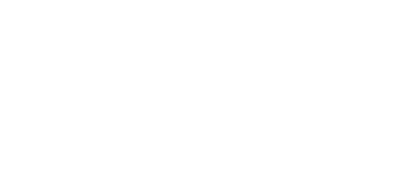Michele Vellano
Commento n. 280 - 19 dicembre 2023
La mattina del 19 dicembre del 1943 sei giovani attivi nella resistenza, due provenienti dalla Valle d’Aosta (Émile Chanoux ed Ernesto Page) e quattro dalle Valli valdesi (Giorgio Peyronel, Mario Alberto Rollier, Gustavo Malan e Osvaldo Coïsson) sottoscrissero la Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine, più nota come Carta di Chivasso. Nella ricorrenza degli ottant’anni da quel giorno, merita ricordare come venne redatta e riflettere sull’attualità del suo contenuto per quanto riguarda, in particolare, la salvaguardia e la promozione delle specificità e prerogative delle comunità locali nel quadro nazionale ed europeo.
La Carta di Chivasso segue e, per certi versi, trova ispirazione nello scritto Per un’Europa libera e unita, conosciuto come Manifesto di Ventotene, redatto, nel 1941, da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi mentre si trovavano al confino nella piccola isola dell’arcipelago Ponziano (dal 2014 gemellata con la Città di Chivasso). Il file rouge che unisce i due documenti è testimoniato dall’amicizia tra Mario Alberto Rollier e Altiero Spinelli, sodalizio che contribuì alla costituzione, il 27-28 agosto 1943, del Movimento federalista europeo proprio nella casa di Rollier, in via Poerio, a Milano. Spinelli, ospite di Rollier a Torre Pellice alcuni giorni dopo, pronunciò un discorso programmatico sul federalismo europeo, episodio ricordato con l’apposizione di una lapide commemorativa recentemente inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La Carta di Chivasso ha, nondimeno, un’impostazione che pone l’accento sulle rivendicazioni autonomiste delle popolazioni alpine che la rendono assolutamente peculiare e, appunto, complementare rispetto al Manifesto di Ventotene. L’aggettivo “locale” viene utilizzato ben quindici volte ed è certamente il termine, non a caso, più ricorrente nel testo della Dichiarazione. L’intuizione dei redattori della Carta di Chivasso consiste, dunque, principalmente nell’avere posto in stretta correlazione la dimensione locale con quella europea e di avere compreso, in anticipo e con estrema lucidità, l’importanza di coniugare il futuro assetto repubblicano dell’Italia, su base regionale, con un’organizzazione, a livello continentale, di tipo federale. L’intento principale era quello di impedire l’eventuale ritorno di uno Stato accentratore e oppressore, in particolare nei confronti delle comunità locali connotate da una lingua e/o da una fede religiosa diverse da quelle della maggioranza della popolazione. Questa nuova impostazione, conseguita attraverso la saldatura tra la dimensione locale e quella europea, avrebbe, di conseguenza, consentito finalmente “l’avvento di una pace stabile e duratura” nel Vecchio continente. Come, in effetti, è avvenuto.
Se il ruolo dei valdostani Émile Chanoux e Ernesto Page (e, in maniera più defilata, di Federico Chabod, che non fu presente all’incontro ma inviò un testo scritto) all’elaborazione del contenuto della Carta di Chivasso è relativamente conosciuto (soprattutto in chiave autonomista), meno noto è l’indiscutibile apporto dato dai quattro giovani e intraprendenti valdesi e, soprattutto, le motivazioni e le rivendicazioni che provenivano dalle Valli in quegli anni terribili e decisivi allo stesso tempo.
Poco nota, in particolare, è l’iniziativa, successiva e coerente con il contenuto della Carta di Chivasso, dei Consigli comunali delle Valli valdesi di portare all’attenzione dell’Assemblea costituente la proposta di istituire un “Cantone delle Valli valdesi” in corrispondenza “dell’alto Pinerolese, in quella zona comunemente denominata delle Valli valdesi” (citata nell’intervento dell’azionista fiorentino Tristano Codignola il 1° luglio 1947 all’Assemblea costituente) e motivata dall’essere quest’ultima “zona mistilingue”.
Benché le rivendicazioni dei redattori valdesi della Carta di Chivasso muovessero evidentemente anche dall’esperienza secolare di autonomia e lotta per salvaguardare la propria fede riformata, le loro richieste erano essenzialmente di carattere amministrativo e relative a tre aspetti tutt’ora molto attuali del decentramento e dell’autonomia territoriale: le politiche amministrative, quelle culturali e scolastiche e, infine, quelle economiche e fiscali.
Tale approccio, sorretto da forte generosità e dalla volontà di ispirare la generalità delle popolazioni alpine, si accompagnò al rapido tramonto del sogno di un Cantone delle Valli valdesi, mentre veniva concesso alla Regione Autonoma Valle d’Aosta uno statuto speciale. Il frutto delle rivendicazioni fu, comunque, conseguito ed è contenuto, tra l’altro, negli articoli 5 (sulle autonomie locali e il decentramento), 6 (sulla tutela delle minoranze linguistiche) e 8 (sul diritto di organizzarsi secondo i propri statuti di tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica) che trovano collocazione nei principi fondamentali (e perciò immodificabili) della Costituzione della Repubblicana italiana.
Oggi la dimensione locale è ben presente, sebbene non in modo sistematico e ordinato, anche nell’impianto dell’ordinamento europeo, come si evince da non poche disposizioni dei trattati vigenti (Trattato sull’Unione europea - TUE e Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE). La ragione principale della prudenza e del disordine dei riferimenti alla dimensione locale nei testi dei trattati dipende, come è ben noto, soprattutto dalla circostanza che questi ultimi sono conclusi da Stati ben attenti a salvaguardare le rispettive prerogative.
Così nell’art. 4 TUE si legge: “L’Unione europea rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali”. Mentre, nell’art. 174 TFUE, dedicato alla politica di coesione economico sociale e territoriali, si precisa che l’Unione “mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali […] le regioni insulari, transfrontaliere, e di montagna”.
L’apporto dell’ordinamento dell’Unione europea alla dimensione locale territoriale assume un significato tutto particolare per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, che costituisce un modello molto avanzato di collaborazione tra enti locali territoriali di Stati diversi e che ha contribuito significativamente a pacificare territori di confine in precedenza teatro di forti tensioni, se non di scontri aperti (si pensi all’Irlanda del Nord, ai Paesi Baschi fino al Südtirol/Alto Adige).
Le riforme che attendono l’Unione europea, a cominciare da quelle formulate il 22 novembre scorso dal Parlamento europeo, devono, allora, andare nella direzione di un ulteriore rafforzamento della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e territoriali. Ad esempio, si potrebbe proporre che il parere del Comitato delle Regioni, in relazione a determinate materie, sia vincolante e non solo necessario. Nel frattempo, gli enti territoriali locali devono rendersi ancora più consapevoli del loro ruolo strategico e, al contempo, di avere nell’Unione europea uno straordinario alleato per quanto riguarda la salvaguardia delle loro specificità e prerogative. Consapevolezza che avevano, con molto anticipo e lungimiranza, i sottoscrittori della Carta di Chivasso già nel 1943.
*Professore ordinario di diritto dell’Unione europea, Università di Torino (versione ampliata dell’articolo pubblicato il 15 dicembre scorso su Riforma.it)
Download PDF - Commento 280

 It
It  En
En